Roma non è una città sicura per le donne: “Serve una rivoluzione culturale prima di ogni altra cosa”
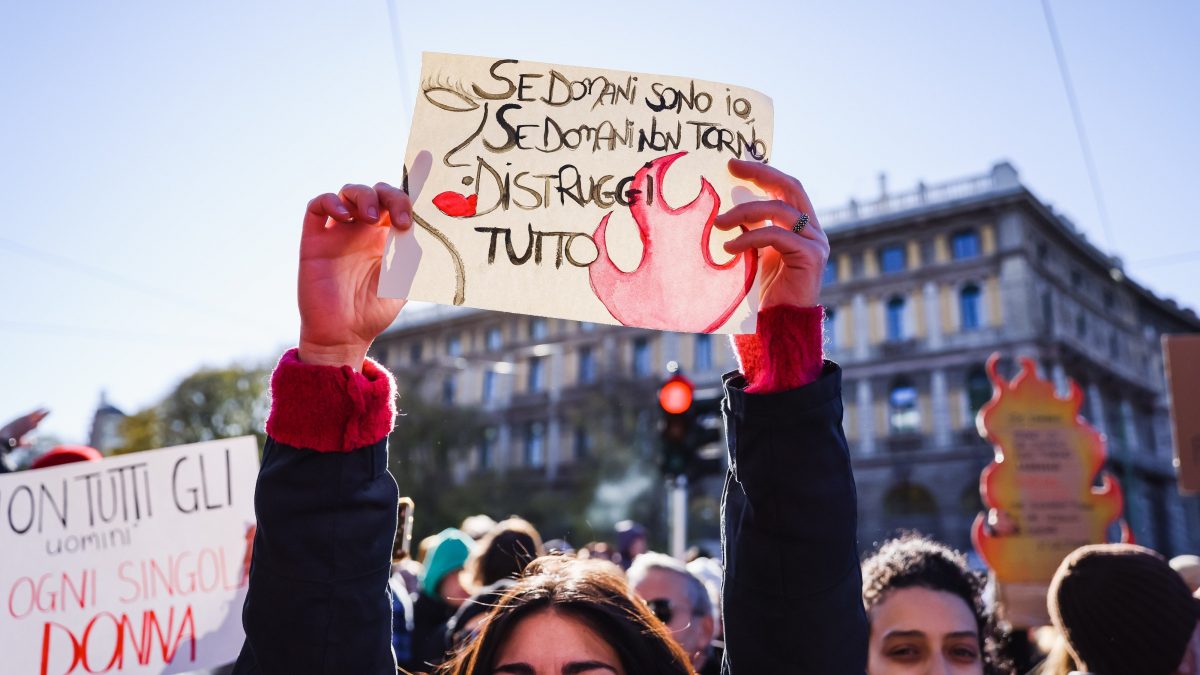
Se si nasce femmine, fin dalla più tenera età ci viene insegnato che il pericolo più grande viene dalla strada. I dati che ogni anno vengono pubblicati, però, ci confermano che non è così e che molte delle violenze che una donna è costretta a subire nell'arco della sua vita avvengono proprio in ambito familiare, all'interno della sua casa. Al netto di questo, però, le strade e la città non sono luoghi sicuri per le donne. E le strade di Roma non fanno eccezione, come dimostra anche quanto accaduto nelle ultime ore a Tor Tre Teste.
Lo diceva, un paio di anni fa, un report chiamato Spatium Urbis, realizzato dalle dottoresse Elisa Leoni e Alice Fischetti, coordinato dalla professoressa e sociologa Mariella Nocenzi e esposto alla presenza di Michela Cicculli, presidente della Commissione pari opportunità al Comune di Roma, che evidenziava come per donne e per le persone non binarie la città potesse rappresentare un pericolo, soprattutto la sera e in alcuni punti considerati "critici", come sottopassaggi e stazioni.
A due anni di distanza, cosa è cambiato? Fanpage.it lo ha chiesto proprio alla professoressa e sociologa Mariella Nocenzi e alla presidente della Commissione Pari Opportunità al Comune di Roma Michela Cicculli che hanno raccontato come si è evoluta la città e quanta strada ancora c'è da fare per far sì che le donne possa riprendersi, o forse, prendersi per la prima volta, lo spazio pubblico.
Roma, città sicura per le donne: a che punto siamo
"Prima di tutto occorre fare una precisazione e approfondire cosa significa spazio pubblico – esordisce Cicculli – C'è quello costituito da piazze, strade, se vogliamo anche i mezzi pubblici e c'è l'altro, quello delle istituzione, il luogo in cui vengono prese decisioni e si formulano idee politiche. E poi, ancora, c'è lo spazio pubblico rappresentato dai servizi". C'è una complessità di elementi a formare lo spazio pubblico: "Di conseguenza, c'è una diversificazione nei modi di agire che non possono ridursi soltanto a temi della sicurezza, sicurezza personale o violenza di genere domestica, dal momento in cui abbiamo abbracciato il paradigma culturale per cui la violenza è una responsabilità pubblica collettiva – spiega – Di conseguenza dobbiamo trovare degli strumenti per contrastarla".
Alcuni temi sono più urgenti. Come agisce il Comune di Roma a tale proposito? "C'è un lavoro continuo rispetto all'apertura di servizi sui territori, in particolare i centri antiviolenza. Legato ai servizi, invece, si apre il tema dell'educazione all'affettività nelle scuole messo in campo dalla Capitale. Un ulteriore tema, che riguarda lo spazio pubblico, si apre sul tema della sicurezza, intesa anche come sociale e civile – aggiunge – E gli sforzi che si fanno per migliorare la sicurezza urbana devono tenere conto anche delle soggettività che nello spazio pubblico, lo sappiamo bene, sono più in pericolo di altre".
Proprio come le donne e le persone non binarie. "In questo caso, ad esempio, stiamo introducendo nel regolamento di Polizia Urbana il tema delle molestie e delle discriminazioni di genere come comportamenti che sono condannati e che quindi sono potrebbero anche essere oggetto di provvedimenti da parte dell'amministrazione. Riteniamo che la convivenza civile passi anche da qui".
Ma non bastano. "Serve anche una sensibilizzazione culturale e personale generale che riguarda, se vogliamo declinarlo nello specifico, il personale che lavora sui mezzi pubblici e che quindi potrebbero potrebbe trovarsi davanti a situazioni di violenza, discriminazione o comunque di vulnerabilizzazione di qualche persona. In quel caso occorre che sia nelle condizioni di poter orientare la persona verso una rete di servizi e intervenire".
Un'altra proposta è quella che riguarda il Progetto Rifugi, per sensibilizzare e formare il personale bibliotecario. "Anche in questo caso è importante che si conosca la rete antiviolenza e che si sappia orientare le utenti, in questo caso, delle biblioteche dando le prime informazioni e presentandosi come soggetto attivo nella promozione della rete antiviolenza – continua Cicculli – Io credo che questa serie di elementi messi insieme costituiscano la sicurezza dello spazio pubblico che non è un obiettivo da raggiungere, ma un processo culturale da alimentare a cui tutti e tutte di avere gli strumenti di consapevolezza necessari per prenderne parte. Soltanto così c'è davvero la presa in carico pubblica della questione della violenza di genere".
Come individuare i problemi della città
Altrettanto complesso, però, è stabilire quali siano i problemi e quali siano i più urgenti all'interno delle città. "Il report Spatium Urbis è stato un unicum, nato da un tirocinio formativo di due studentesse", puntualizza la professoressa Mariella Nocenzi, che ha coordinato le ricerche, precisando che rilevare informazioni così precise è spesso molto più complicato. "Spesso mancano gli strumenti. Abbiamo alcuni dati, ma molti sono assenti: il grande problema della rilevazione dei fenomeni collegati alla condizione femminile è che i dati che abbiamo talvolta non sono declinati sul genere, perché si tratta di rilevazioni ISTAT".
La situazione talvolta può migliorare nella capitale: "A Roma ci sono dei servizi erogati dal Comune, ci sono altre rilevazioni dalle università. Qualche dato sulla città in ottica di genere può emergere, ma anche in questo caso non si tratta di dati sistematici e spesso non sono integrati tra loro. Per leggere fenomeni di questo tipo, invece, è più utile agire con piccole ricerche oppure andando ad approfondire con interviste qualitative con i singoli soggetti, spesso donne, operatrici di servizi per le donne tramite cui riusciamo a ricavare temi, tendenze, istanze che stanno emergendo e che magari nella rappresentazione pubblica, nell'immaginario collettivo neanche sono così evidenti".
Nelle città uno dei temi più studiati, come precisato dalla professore, è quello della violenza e quindi anche delle rilevazioni sui con i CAV, nei centri antiviolenza che prendono in analisi i dati. Soltanto la settimana scorsa, a questo proposito, sono stati condivisi i numeri degli accessi al Codice Rosa in pronto soccorso, da un'indagine svolta dalla Società italiana di medicina d'emergenza urgenza, Simeu: soltanto in un anno si contano 250mila segnalazioni di violenza sulle donne.
Un cambio di paradigma: "Tornare civili"
Non sempre però è facile individuare nello spazio urbano le forme di violenza di genere, tenerle sotto controllo e arginarle. "Succede perché c'è meno responsabilizzazione, proprio perché si tratta di uno spazio pubblico e non di uno privato. Per questo dobbiamo rivedere i paradigmi culturali agendo come possiamo. Un'operazione culturale che ci mette davanti alla necessità individuale di metterci in discussione, non solamente dal punto di vista della relazione con il partner, ma dal punto di vista della relazione con le soggettività che stanno nello spazio pubblico, ad esempio, è quella costituita dal Mupa, il Museo del Patriarcato, promosso da ActionAid". Che, non a caso, è stato preso di mira da quella certa destra che non riesce a fare i conti col fatto che il cambiamento possa passare anche da qui.
"Occorre favorire delle attivazioni civiche di responsabilizzazione e di rompere il paradigma culturale vittima e carnefice che non trova spazio in un paradigma culturale di questo genere".

Roma pericolosa: la sicurezza in strada
Come agire, invece, nello spazio pubblico fisico, che ci circonda? Le cronache raccontano di episodi di violenza nei sottopassaggi romani, nelle strade più isolate. C'è chi suggerisce più illuminazione e chi più agenti per strada.
Un punto di vista profondamente pratico sull'evoluzione urbana della città arriva dalla professoressa Nocenzi. "Un elemento positivo in questo senso è arrivato a Roma dal punto di vista economico, con gli investimenti del PNRR sulla città, soprattutto quelli finalizzati al al Giubileo, perché ci sono state aree riqualificate. Questo significa maggiore illuminazione e presenza delle forze dell'ordine, ma soprattutto una ripianificazione degli spazi più a misura anche di donna, basti pensare alle piazze più ampie e senza anfratti. Anche questo può fare la differenza, soprattutto di notte o quando è meno presidiata", dice. Ma lavorare sulla città non basta se le procedure burocratiche sono così lunghe: "Andrebbero riformulate e snellite, per fare sì che, quando arriva un finanziamento, questo possa essere velocemente impiegato nelle opere pubbliche: non possono trascorrere decenni, come avvenuto con la metro C ad esempio", conclude poi.
"Il tema delle infrastrutture è un tema centrale perché sono quelle condizioni che permettono di usufruire della città di giorno, di notte, chiunque tu sia e di farlo in comodità, in sicurezza e accessibilità. L'infrastruttura è utile e deve esserci un investimento per il settore pubblico – aggiunge Cicculli – Ma non possiamo pensare che bastino come risposte al tema di sicurezza che, invece, deve fare i conti prima con la sicurezza sociale: non farlo sarebbe un errore culturale che non ci permetterebbe di andare avanti con l'evoluzione della responsabilizzazione già citata".
Donne nell'amministrazione: sono loro che rendono le città più sicure?
Fra gli aspetti positivi anche che molte donne si trovino ad amministrare la città. "Il numero di donne presenti al livello municipale, comunale, regionale e nazionale è in crescita. Ora, personalmente, non come ricercatrice, sono poco contenta di molte donne che sono al potere oggi, ma sono convinta che possano portare un punto di vista nuovo, una sensibilità anche femminile – ammette la professoressa Nocenzi – Lo abbiamo già visto anche nei Cda delle attività economiche, delle società quotate in borsa. Lo vediamo anche alle elezioni con la doppia preferenza. Secondo me introdurre le donne nelle istituzione può portare un contributo nuovo verso un cambiamento che è progressivamente visibile, un'impronta anche nei provvedimenti e nelle normative che riguardano anche la gestione della città, come affermano anche studi internazionali. Lo sguardo femminile è importante quanto quello maschile e imprime un cambiamento da cui si possono cogliere nuove istanze".
Di diversa opinione, invece, è Cicculli: "Trovo che sia una visione naturalista che non condivido. Non penso che le donne abbiano sensibilità maggiori rispetto ad altre donne, uomini e altre soggettività, che siano determinate nelle loro azioni da ruoli di genere che vengono da anni di socializzazione, stereotipi, pregiudizi o dinamiche patriarcali – precisa – Non credo che le donne nell'amministrazione possano fare la differenza. Credo invece che si possa portare un paradigma culturale diverso all'interno delle amministrazioni a partire dai ruoli dalla messa in discussione dei ruoli di genere. Qui le donne possono avere un protagonismo, su questo sono d'accordo".
La necessità di un cambiamento culturale: non bastano aiuti economici
Finanziamenti, infrastrutture. Ma tutto, per Cicculli come per Nocenzi, deve avvenire sotto l'egida di un cambiamento culturale. "Serve ripensare la cultura sotto un altro sguardo", concorda la professoressa Nocenzi. Questo appare lampante fin dal microcosmo familiare. Nel report di due anni fa, ad esempio, dai dati emergeva un maggiore impegno delle donne nei lavori di cura. "Oggi c'è un maggiore equilibrio nei ruoli rispetto alla cura, ma non basta, servono anni per cambiamenti culturali di questo tipo – sottolinea la docente – Inutile riservare mille euro a ogni nuovo nato, non servono contributi economici a pioggia ma investimenti seri anche nell'occupazione femminile. Le ragazze son più brave negli studi, ma soffrono una condizione di maggiore povertà e di disagio".
Un dato che ancora una volta è stato confermato quest'anno nella capitale: a Roma le donne guadagnano in media il 25% in meno dei colleghi uomini di pari livello. Una situazione che si riflette anche sui contributi che arrivano con le pensioni. "E questa non può che essere una forma di peggioramento della qualità della vita delle donne – continua – Occorre invece disporre un miglioramento. E questo passa da diversi aspetti, compreso l'abbattimento dei ruoli di genere come li abbiamo conosciuti finora, sotto un'ottica patriarcale".
Per farlo non c'è altra alternativa alla formazione e all'educazione sessuoaffettiva. "Poiché la società va cambiata tutta, però, non deve essere rivolta soltanto ai giovani che, talvolta, sono già consapevoli. Anche per questo sono assolutamente a favore della formazione continua anche altrove, come nei luoghi di lavoro. È una questione troppo importante per lasciarla soltanto ai giovani. Senza considerare, poi, che da un punto di vista sociologico e storico chi rientra nelle generazioni definite boomer dovrebbe essere più naturalmente predisposto al cambiamento, avendo attraversato gli anni delle rivoluzioni culturali, dagli hippie alla seconda ondata femminista. Sono loro che hanno vissuto, attraverso i loro occhi, il cambio radicale della figura della donna che, da angelo del focolare, è entrata nel mercato del lavoro e ha guadagnato la sua indipendenza".
Una rivoluzione che ha subito un'involuzione negli ultimi decenni. "Oggi i tempi sono maturi per uscire da questa rivoluzione in negativo che ha caratterizzato gli anni Ottanta e Novanta in primis". Ed estirpare il problema alla radice. "È vero che il problema della violenza di genere è ovunque diffuso con picchi più o meno evidenti, ma bisogna pure vedere le cause e le dinamiche sociali che sono alla base – continua Nocenzi – In Italia mi sembra che ci sia veramente una resistenza culturale di tipo patriarcale che continua, nonostante le campagne di sensibilizzazione, a dominare nei libri scolastici, nelle rappresentazioni televisive. Ed esiste. Con l'educazione sessuo-affettiva, però, si può mettere in discussione tutto questo. Potrebbe farsi portatrice di un cambiamento socioculturale che la scuola dovrebbe farsi carico di assumere".

Per fare sì che funzioni, però, occorre che si agisca con un programma transdisciplinare.
"Alcuni modelli che si stanno profilando restano legati al tema sanitario, come nelle proposte arrivate dal ministro Valditara. Ma secondo me, e non per tirare l'acqua al mio mulino, occorre intervenire anche da un punto di vista sociologico e multisciplinare per garantire l'efficacia". E il raggiungimento degli obiettivi posti fra i primi l'introduzione di una cultura del consenso.
"Questo, tornando all'idea di una città sicura per le donne, potrebbe fare la differenza sulle nostre strade. Sicuramente ad oggi per noi tutto questo rappresenta una sfida sotto vari settori, banalmente anche quello giuridico e civile: sapere di cosa parliamo quando parliamo di consenso e riconoscere un atto di violenza naturalmente fa la differenza nell'interazione tra due soggetti e permette di cambiare le modalità di socializzazione".
Roma, come può diventare una città sicura per le donne
Per fare la differenza e rendere Roma una città sicura Cicculli non ha dubbi: "Serve educare al consenso e mettere in discussioni il paradigma culturale attuale. Bene migliorare i servizi pubblici che si occupano di politiche di genere, ma in generale occorre portare l'ottica di genere in tutte le politiche pubbliche, anche sulla questione dei trasporti. A fare la differenza è la formazione: questioni come questa sono elementi prioritari – spiega – Necessario, però, anche che ci siano alleanze chiare fra istituzioni culturali e organizzazioni governative che in qualche modo rappresentano quel diverso modo di vedere il mondo che potremmo definire femminista".
Ma la vera chiave per far diventare le città sicure per le donne è quella di agire sugli uomini. "Credo che sia importante approfondire il maschile e la mascolinità tossica evitando però di fare semplificazioni – anticipa – La messa in discussione del maschile è fondamentale per la decostruzione del patriarcato. Ed è importante che, come storicamente avvenuto per il movimento femminista, abbia una sua autonomia: devono trovare loro gli strumenti per farlo". In questo 25 novembre, Giornata internazionale per il contrasto alla violenza di genere, devono essere loro, gli uomini, a mettersi al lavoro. Soltanto così le strade delle città saranno sicure per le donne (e non solo).


