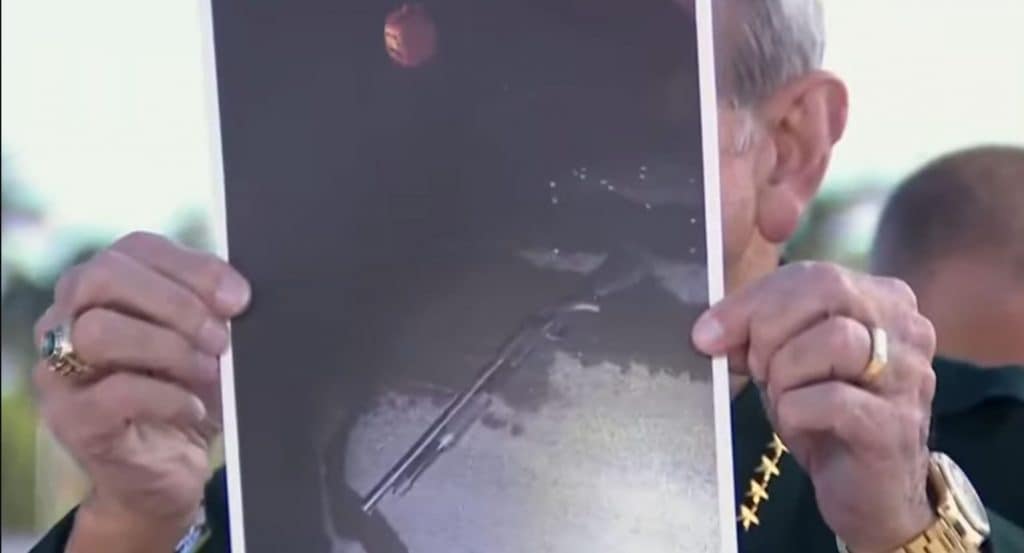Il governo vuole affidare al Garante della Privacy i diritti dei richiedenti asilo: cosa significa e quali sono i rischi

In Italia, la tutela dei diritti dei richiedenti asilo sta per assumere una forma inedita ed estremamente controversa. Il governo ha infatti deciso di affidare al Garante per la Privacy la supervisione delle procedure di frontiera e delle strutture in cui i migranti saranno temporaneamente trattenuti durante l'iter accelerato previsto dal nuovo Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, in vigore da giugno 2026.
Ma la domanda sorge spontanea: proteggere la privacy significa anche essere in grado di garantire la dignità e i diritti fondamentali di chi si trova temporaneamente privato della propria libertà? E poi, quali sono i limiti e le sfide di affidare a un organismo concepito per la tutela dei dati personali un compito che riguarda la vita concreta delle persone, le loro condizioni di accoglienza e la protezione dei loro diritti umani?
Perché il governo vuole affidare al Garante il monitoraggio dei diritti dei richiedenti asilo
Il nuovo Patto dell'Unione Europea sulla migrazione e l'asilo, che entrerà in vigore il prossimo giugno, stabilisce l'obbligo per ogni Stato membro di istituire un'autorità indipendente in grado di garantire il rispetto dei diritti umani dei migranti in tutte le fasi dell'accoglienza e dello screening alle frontiere. In altre parole, Bruxelles richiede a ciascun paese di dotarsi di un organismo capace di ispezionare strutture, monitorare le condizioni di detenzione e assicurare che le procedure di espulsione o di richiesta d'asilo non violino i diritti fondamentali.
L'Italia, però, non possiede un'istituzione nazionale dedicata ai diritti umani né un difensore civico specializzato nella tutela dei migranti; il governo avrebbe dunque individuato nel Garante per la Privacy l'ente "più idoneo" a svolgere questa funzione, proprio per sopperire a questa lacuna, assegnandogli così un budget di ben 10 milioni di euro per monitorare dodici hotspot e numerose questure, strutture che complessivamente offrono circa 10mila posti su tutto il territorio nazionale.
Una scelta che ha suscitato già grosse critiche da parte di giuristi, costituzionalisti ed esperti di diritti umani. Storicamente, il controllo sulle condizioni di detenzione e sulle strutture dove vengono trattenuti cittadini stranieri spettava al Garante per i diritti delle persone private della libertà personale, un organo specializzato nelle ispezioni di carceri, centri di trattenimento per migranti, reparti psichiatrici e altre strutture simili. Affidare ora queste competenze al Garante per la Privacy comporta il rischio non solo di rendere le verifiche meno approfondite, ma soprattutto di mescolare due ambiti giuridici molto diversi: da un lato la protezione dei dati personali, dall'altro, appunto, la tutela dei diritti fondamentali in contesti di restrizione della libertà.
Quali sono i rischi
Proteggere i dati personali significa garantire che le informazioni su ciascun individuo siano raccolte, trattate e conservate nel rispetto della legge, che non vengano diffuse senza consenso e che siano rispettati principi di trasparenza e sicurezza; si tratta, cioè, di un ambito tecnico e giuridico, che risponde a regole precise, strumenti di controllo definiti e sanzioni per chi le viola.
Dunque tutelare la privacy non equivale a proteggere i diritti umani, intesi specialmente in contesti in cui la libertà è limitata o sospesa. La protezione dei diritti fondamentali richiede infatti uno sguardo molto più ampio e diretto: significa verificare le condizioni materiali in cui le persone vivono, accertarsi che non subiscano trattamenti degradanti o inumani, garantire accesso a cure sanitarie, istruzione, assistenza legale e psicologica, e protezione giuridica effettiva. Richiede dunque esperienza sul campo: ispezionare le strutture, parlare con chi vi è detenuto, capire situazioni di abuso che spesso non emergono dai documenti ufficiali.
Affidare quindi a un'autorità come il Garante per la Privacy un compito del genere comporterebbe in sostanza il rischio concreto di ridurre la tutela delle persone a un controllo puramente burocratico; il monitoraggio potrebbe limitarsi a controllare registri, protocolli o sistemi informatici, senza valutare se le condizioni di detenzione siano effettivamente compatibili con la dignità e i diritti dei migranti. Problemi invece concreti, come l'isolamento, la mancanza di assistenza legale, difficoltà di accesso a interpreti, supporto psicologico assente, carenze sanitarie o condizioni igieniche inadeguate, rischierebbero così di rimanere invisibili o ignorati.
In altre parole, la privacy può proteggere i dati dei migranti dall'uso improprio, ma non può impedire abusi, violenze o violazioni della libertà personale all'interno di un hotspot o di un centro di trattenimento. Per questo motivo, molti esperti ritengono problematica la scelta di affidare al Garante per la Privacy la supervisione dei diritti umani dei richiedenti asilo: si rischia cioè di rispondere formalmente agli obblighi europei senza garantire la sostanza della tutela, trasformando un diritto fondamentale in un mero adempimento tecnico.
Insomma, il Patto europeo potrebbe diventare non solo una scadenza da rispettare, ma un vero banco di prova simbolico, perché l'Italia dovrà spiegare all'Europa come intende garantire gli standard di tutela dei diritti umani. Ma resta il nodo centrale: come dimostrare concretamente questa protezione? Affidarsi al Garante per la Privacy come unico strumento di supervisione rischia di ridurre la risposta a una semplice messa in scena, capace di dare l'apparenza di rispetto delle regole senza assicurare realmente la sostanza della tutela, come una facciata che sembra solida ma che può crollare di fronte alla realtà.