Segui Scanner.
Segui la rassegna stampa per capire il mondo, ogni mattina.

Ieri il Parlamento Europeo ha dato il via libera definitivo all’EDIP (European Defence Industry Programme), un tassello cruciale nella road map che impegna la Commissione a un massiccio investimento nel riarmo continentale. Un programma che, sebbene presentato sotto l’egida dell’innovazione e della difesa comune, solleva un interrogativo inquietante: l'Europa si sta preparando alla guerra, e a quale costo?
Il Bazooka Militare contro la Spesa Sociale
Questa spinta al riarmo è trainata in particolare dai paesi baltici e dalla Polonia, storicamente "falchi" nei confronti della Russia, e dalla Germania che ha annunciato un vero e proprio "bazooka economico" interno per potenziare le proprie forze armate.
Ma questo dispiegamento di risorse avviene in un contesto economico europeo (e italiano in particolare) già in forte difficoltà. Ogni anno, la legge di bilancio è dominata dalla retorica sulla necessità di tagliare la spesa pubblica e i servizi essenziali a causa delle scarse possibilità di investimento. Oggi, invece, si trovano miliardi da dirottare sull'industria bellica.
L'obiettivo dichiarato è una "difesa comune" che porti l'Europa a essere "pronta" entro il 2030. La parola "guerra" viene evitata, ma è l’unica logica conseguenza di una corsa agli armamenti che ignora l’investimento in percorsi diplomatici e la sicurezza sociale delle persone.
Il Nemico Evasivo: Russia o il "Sud"?
Il vero nemico dell’Europa, in questa nuova politica di potenza, appare sfuggente. È la Russia di Putin, come suggerito dall'impulso dei paesi più vicini al conflitto ucraino e dai leak dei servizi segreti britannici, che indicano il 2035 come possibile scadenza per un conflitto?
Oppure la minaccia è il "Sud", come suggerito dalle recenti, imbarazzanti e sorprendenti dichiarazioni del Ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani, che ha ventilato l'utilità del Ponte sullo Stretto in caso di evacuazione per un attacco da Sud?
Questa ipotesi apre scenari paradossali: i possibili nemici potrebbero essere la Tunisia di Saied, autocrate con cui l'UE e l'Italia vanno a braccetto; la Libia di Al-Masri, cui paghiamo per fermare i flussi migratori; o l’Egitto di Al-Sisi, destinatario di quella che fu definita la “commessa del secolo” di armi italiane, in una sorta di imbarazzante scambio dopo l'omicidio di Giulio Regeni. Come se potesse davvero compensare la sua perdita.
L'impressione è che, al netto di queste ambiguità, il vero scontro politico ed economico si stia consumando, con un riferimento anacronistico, tra "imperi": quello della Russia di Putin, della Turchia di Erdogan, e gli Stati Uniti di Trump, in un richiamo alla corsa al riarmo pre-Prima Guerra Mondiale.
Il Rischio dell'Indebitamento Solitario
Il problema militare centrale è l'approccio: l'Europa tenta di non restare schiacciata, ma lo fa con una strategia di riarmo nazionale anziché con una politica estera e di difesa realmente coordinata.
I governi sovranisti resistono alla cessione di sovranità militare, e il risultato è che avremo 27 paesi membri con eserciti armati individualmente, con una spesa esorbitante e un reale indebitamento per le generazioni future, senza però una vera e propria "difesa comune" operativa. Spenderemo tantissimo, ma non saremo davvero pronti.
Non è in discussione l'orrore per il regime di Putin, almeno io non avevo bisogno dell'invasione dell'Ucraina per condannarlo. Piuttosto, è in discussione la scelta dell'Europa:
Non si può accettare di diventare un suddito degli Stati Uniti, un loro avamposto pronto a combattere sul proprio suolo una guerra che l’ha già precipitata nel baratro più volte: Prima e Seconda guerra m ondiale oltre alla guerra di Jugoslavia.
La pace è davvero la vittoria di tutti. È ora che l'Europa investa sulla diplomazia, sui percorsi di pace, per ritagliarsi un ruolo di autonomia politica e non di avamposto militare. La corsa al riarmo, finora, ha portato solo guerre.
La corsa al riarmo, come unica risposta geopolitica, è la facile scorciatoia. La diplomazia è la via difficile, ma è l'unica che non promette nuove tragedie.
Non possiamo permetterci di far coincidere la "difesa comune" con la sola moltiplicazione di cannoni e fregate. L'alternativa al militarismo non è l'ingenuità, ma l'intelligenza strategica. L'Europa, con la sua forza economica e la sua storia travagliata, ha il potenziale e il dovere di diventare un mediatore globale autonomo, e non il campo di battaglia per procura di altre potenze.
Mentre l’EDIP impegna miliardi nell’acciaio e negli algoritmi di guerra, l'Europa dovrebbe invece lanciare un Programma Europeo per l’Investimento in Pace e Sicurezza Umana, destinando fondi massicci alla risoluzione dei conflitti, alla prevenzione diplomatica e al rafforzamento delle istituzioni internazionali, dalle Nazioni Unite fino ai tavoli di dialogo regionale. L'alta rappresentante per la Politica Estera e la Commissione, anziché accelerare la spesa militare, dovrebbero concentrare ogni energia sulla creazione di un canale di comunicazione privilegiato con ogni attore globale, anche i più ostili.
Essere "pronti" per il 2030, come si prefigge Bruxelles, non deve significare solo essere armati fino ai denti. Deve significare, innanzitutto, essere capaci di evitare il conflitto. Se l’Europa, schiacciata tra la retorica della minaccia russa e le incertezze americane, non trova rapidamente una sua voce diplomatica e neutrale, sarà costretta a usare le armi che sta comprando.
E la storia ci insegna che, su questo continente, quando si inizia a sparare – in nome della difesa, dell'onore o della deterrenza – la guerra diventa rapidamente la regola, non l’eccezione. Il prezzo di questa nuova "pace armata" lo pagheranno i nostri figli, indebitati per una guerra che potremmo, e dovremmo, essere in grado di prevenire con la forza della politica. Investire sulla pace è, oggi, l'unica vera mossa di difesa strategica.

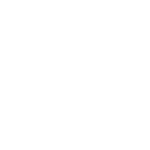
;Resize,width=727;)




