
Si potrebbe pensare che Stefano Sollima abbia realizzato una serie classica sugli otto duplici omicidi che hanno terrorizzato la Toscana per diciassette anni. Parliamo invece di qualcosa di più profondo, più insidioso, più difficile da guardare negli occhi: la violenza strutturale che abitava le famiglie contadine degli anni '60 e '70. Quella violenza invisibile che non lascia cadaveri nei boschi ma anime spezzate dentro case di pietra, dove le donne valevano quanto le pecore da scambiare in dote (se non meno) e gli uomini più deboli imparavano a soffocare qualsiasi emozione pur di sopravvivere.
Il Mostro, la miniserie in quattro episodi disponibile su Netflix dal 22 ottobre (in coincidenza con il decimo anniversario del servizio in Italia), prende il caso che ha ossessionato una generazione come pretesto per spalancare le porte su un universo parallelo di orrore quotidiano. E lo fa con una scelta coraggiosa quanto controversa: ignorare, almeno per adesso, la narrazione mediatica più famosa – quella di Pietro Pacciani e dei "compagni di merende" – per partire dall'inizio, dalla cosiddetta "pista sarda", quella traccia investigativa che ha tenuto banco negli anni '80 prima di chiudersi nel 1989 con un nulla di fatto.
Quattro uomini, quattro gradazioni di violenza

La struttura narrativa è chirurgica. Quattro episodi, quattro punti di vista, quattro uomini intrappolati in una ragnatela di sospetti, vendette e silenzi: Stefano Mele, Francesco Vinci, Giovanni Mele, Salvatore Vinci. Ognuno porta sulle spalle un fardello diverso di violenza sopportata o perpetrata. Ognuno incarna una sfumatura diversa di quel sistema patriarcale che Sollima seziona con grande freddezza.
L'arco temporale viaggia dalla fine degli anni '60 alla metà degli '80, seguendo le indagini su quel primo duplice omicidio del 1968, quello di Antonio Lo Bianco e Barbara Locci – quello per cui Stefano Mele, marito della Locci, fu condannato, ma che anni dopo si rivelò collegato ai successivi delitti del Mostro grazie ai bossoli ritrovati nel fascicolo. Un dettaglio balistico che trasformò una storia di corna e vendetta in un incubo giudiziario durato un decennio, travolgendo tutti i sardi coinvolti nella vicenda mentre il vero serial killer continuava a uccidere.
La donna come bestiame
In questo universo claustrofobico, la donna non è mai protagonista. È merce di scambio, oggetto di possesso, causa scatenante di tragedie maschili. I matrimoni si combinano sulla base di terre e pecore, le mogli vengono abbandonate e tradite, usate dagli uomini anche per coprire relazioni omosessuali. Non c'è spazio per l'interiorità femminile, per la voce di chi subisce. O meglio, c'è, ma il punto di vista maschile è più forte. Soverchiante.
Questa scelta – mostrare il tutto attraverso gli occhi di chi abita quel sistema – è il vero colpo di genio della serie. Sollima non ci offre vie di fuga morali, non ci regala personaggi con cui identificarci completamente. Anche perché ogni episodio aggiunge o toglie un tassello di verità. E questo costringe chi guarda a stare dentro questa logica distorta, a respirare quell'aria mefitica, a capire dall'interno come un contesto sociale possa generare i "mostri".

Dialoghi come pugni nello stomaco
Asciutti, sporchi, poco rifiniti, impregnati di dialetto sardo. I dialoghi del Mostro ti costringono a sporgerti in avanti, a fare fatica, a sentirti straniero in quella lingua aspra che è anche lingua di violenza, di minacce sussurrate, di "mettimi mezzo bicchiere di acquavite" e "tuo marito? tuo marito non lo servi?". Non c'è nulla di letterario in queste conversazioni. Sono scambi brutali. La lingua diventa essa stessa strumento di oppressione e, paradossalmente, di sopravvivenza.
L'assenza strategica del contesto

Una scelta è senz'altro l'assenza quasi totale di aperture verso il contesto socio-politico dell'Italia di quegli anni. Non c'è spazio per gli anni di piombo, per le trasformazioni sociali, per nulla che non sia strettamente funzionale al punto di vista dei quattro protagonisti e al loro rapporto con le indagini. Sollima sigilla ermeticamente la narrazione dentro i confini di quel microcosmo. È una scelta che può apparire limitante, ma che in realtà serve a rinforzare la claustrofobia di quel mondo: un mondo dove non esistono vie d'uscita, dove l'orizzonte non si allarga mai oltre quella mentalità ristretta.
Il Mostro è una serie difficile, ostica, che non offre consolazioni. Non scioglie nodi, non fornisce risposte, non ti lascia il conforto di aver capito. Ti lascia solo con la consapevolezza che l'orrore vero non è mai quello che fa notizia, come gli otto duplici omicidi del "mostro", ma quello che si consuma ogni giorno dentro le mura domestiche, invisibile agli occhi di chi non vuole vedere.

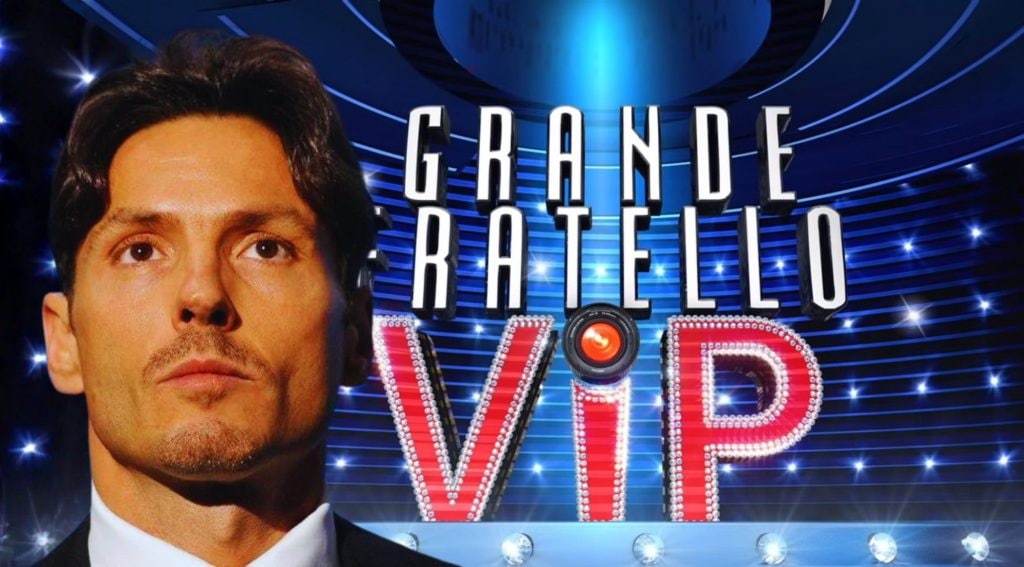
;Resize,width=369;)
;Resize,width=369;)
;Resize,width=369;)

