Iscriviti a Evening Review.
Ricevi la rassegna speciale a cura di Adriano Biondi

C’è una cosa su cui analisti politici di diverso orientamento possono concordare: il voto dei cittadini di Puglia, Veneto e Campania non è destinato ad avere ripercussioni importanti sugli assetti politici italiani nel breve e medio periodo. Sappiamo chi saranno i nuovi governatori e registriamo qualche spostamento interessante negli equilibri interni alle coalizioni. Globalmente, nel 2025 assistiamo a una tenuta del centrosinistra (che ora governa in Sardegna e Umbria), malgrado la forza del vento che spira da destra e fa veleggiare la barca di Giorgia Meloni. Salvini esce leggermente rafforzato e Schlein porta a casa due Regioni con candidati che non sono espressione della sua segreteria, ribadendo di avere a cuore un solo appuntamento: le Politiche del 2027. Meloni si prepara a chiedere la Lombardia, dopo l'ennesimo buon risultato di Fratelli d'Italia. Ma tutto sommato poca roba e poco altro.
Eppure, diverse erano le peculiarità e le incognite di questa ultima tranche di Elezioni Regionali del 2025. Se le prime consultazioni avevano mostrato una sostanziale cristallizzazione degli equilibri e ribadito come il consenso (di quei pochi che ancora si recano a votare) si indirizzi essenzialmente su chi già detiene il potere, nel caso delle tre Regioni al voto a novembre eravamo potenzialmente in presenza di condizioni diverse.
Ai nastri di partenza non c'erano i tre governatori uscenti, per cominciare. In casi del genere, l'idea è che possa aprirsi una finestra di opportunità per l'opposizione, che dovrebbe sfruttare gli effetti della spartizione dell'eredità del governatore uscente e una certa "voglia di cambiamento" dell'elettorato.
Poi andava rilevato che la scelta dei candidati dei principali schieramenti politici, praticamente ovunque, non era stata priva di conseguenze e non sempre aveva seguito percorsi lineari. Al punto che era emerso un elemento piuttosto interessante, soprattutto per gli addetti ai lavori: nell’idea che il risultato finale fosse già in qualche modo indirizzato, l’attenzione si era concentrata principalmente sulla composizione delle liste e sugli equilibri interni a partiti e coalizioni, con tutto ciò che comportava in termini di “impegno” dei singoli candidati e di frizioni fra alleati o correnti. Qualcosina, in effetti abbiamo visto: le dichiarazioni di De Luca, i mal di pancia di Emiliano, la presenza totale di Zaia. Niente di trascendentale.
Infine, c'era il quadro complessivo, che suggeriva la possibilità di un massiccio investimento, in termini politici e comunicativi, da parte di maggioranza e opposizione nella campagna elettorale delle ultime tre Regioni al voto in questo 2025. Investimento che, in effetti, c'è stato, con un'esposizione persino eccessiva dei leader di partito (probabilmente funzionale a distogliere l'attenzione da altre e più complesse situazioni).
Nonostante ciò, la tornata elettorale si è svolta in un clima di sostanziale disinteresse da parte dei cittadini e degli elettori delle Regioni interessate, come testimonia ancora una volta il dato sull'affluenza.
L'affluenza alle urne, il disinteresse, le vittorie scontate
La considerazione che sentirete ripetere più spesso in queste ore sarà: "Eh, ma tanto già si sapeva chi avrebbe vinto, ci credo che la gente non è andata a votare". Che è chiaramente un'inversione causa-effetto. Il punto, infatti, è capire come mai sia apparso chiaro fin da subito come nessuna delle Regioni fosse davvero contendibile. E come mai non ci sia mai stata partita e quella finestra di cui parlavamo prima non si sia mai realmente aperta.
A mio parere, sarebbe un errore considerare l'assenza di competitività delle proposte alternative alle maggioranze uscenti come un fatto casuale, o comunque frutto di dinamiche esclusivamente locali. È probabilmente il sintomo di una crisi più grave, di una politica che esiste solo nella misura in cui riesce a tutelare specifici interessi ed è dunque completamente sovrapponibile al livello amministrativo.
Crisi che riguarda tutta la politica, ma che sul livello locale diventa dirimente, anche in considerazione della trasformazione di senso e peso delle Regioni e dei Comuni. Apparati spesso giganteschi, ma che vengono percepiti dai cittadini più come organismi tecnici che come dei luoghi in cui "si fa politica".
In altre parole, sui territori c'è ormai pochissimo spazio per la mobilitazione del voto di opinione o per istanze che in qualche modo superino la dimensione meramente gestionale-amministrativa. In un contesto in cui la funzione dei partiti è di mera rappresentanza di interessi e di gestione ordinaria della cosa pubblica e non invece di formazione dell'opinione, di cambiamento della società in nome di principi e ideali, le campagne elettorali ormai mobilitano esclusivamente apparati e gruppi di potere.
E se l'unica cosa che conta è vincere, perché l'unica cosa che conta è gestire il potere, i criteri per la costruzione dell'offerta elettorale saranno sempre gli stessi: compromessi, valorizzazione dei portatori di voti, subordinazione delle istanze politiche al pragmatismo e al buonsenso, eliminazione della componente ideale quando rischia di essere divisiva, continuità nella gestione amministrativa come elemento cardine per la raccolta del consenso. Processi che sono in atto da tempo e che hanno da tempo trasformato l'amministrazione della cosa pubblica in una macchina elettorale che lavora a ciclo continuo. A pesare non è più l'opinione pubblica, ma grandi e piccoli gruppi di potere sui territori, ormai gli unici in grado di mobilitare gli elettori al momento del voto.
I leader dei partiti, tutti, si muovono in questo modo. E, fateci caso, salvo casi eccezionali (che poi appunto producono esiti infausti alle elezioni), non c'è mai nessuno che sul livello regionale porti un progetto realmente "nuovo", che abbia la forza di tagliare i ponti con il passato, che sia in grado di promettere e praticare davvero una discontinuità nelle scelte, negli obiettivi, nella costruzione della squadra.
Nessuno ha la forza, il coraggio o più semplicemente l'interesse a rompere questo circolo vizioso.
Puoi essere un ex francescano grillino che ha sempre predicato la propria diversità rispetto alla gerontocrazia e al trasformismo, puoi essere un giovanissimo politico che sa già di poter vincere in carrozza la competizione elettorale, puoi essere un candidato fortissimo in grado di prendere decine di migliaia di preferenze, il risultato non cambia: dietro frasi come "mantenere l'unità della coalizione", "dare continuità al buongoverno", "salvaguardare l'azione amministrativa delle esperienze precedenti", "trasformare la Regione in un laboratorio politico", si nasconde sempre la stessa cosa. Ovvero, la paura dell'abisso: mobilitare l'opinione pubblica intorno a un vero progetto politico, tornare a occuparsi dei problemi concreti delle persone, lavorare mesi, forse anni, a una piattaforma programmatica che tenga dentro esperienze e istanze. E comunicare tutto ciò in modo incisivo, chiaro, senza ambiguità.
Troppa faticoso e troppo rischioso, in effetti. Meglio continuare così, in fondo le cose stanno andando benissimo, no?

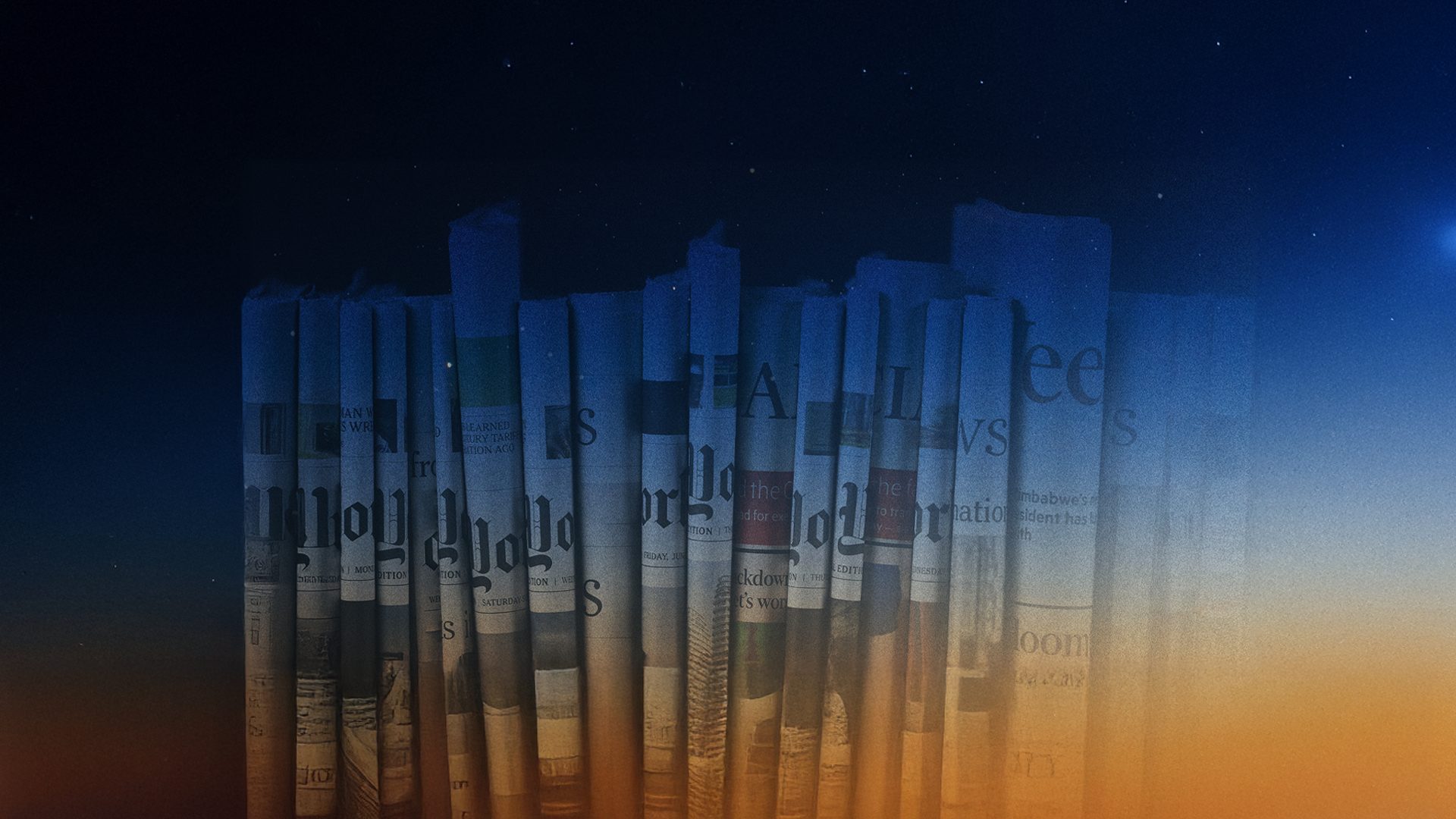;Resize,width=727;)




