Iscriviti a Evening Review.
Ricevi la rassegna speciale a cura di Adriano Biondi

La vicenda molto probabilmente la conoscete: la pubblicazione sul Fatto Quotidiano di un pezzo scritto da Selvaggia Lucarelli in cui si parla del contenuto di una chat tra cinque influencer/divulgatori. O meglio, si rende conto del contenuto di una parte degli atti giudiziari relativi a denunce per stalking e diffamazione nei confronti di tre attiviste, concentrandosi in particolare su quanto rinvenuto nel telefono di una di loro, Carlotta Vagnoli (le chat riportate negli atti in realtà sono diverse, con soggetti diversi). Una vicenda che ha avuto un’enorme rilevanza, non soltanto per il seguito di chi ha pubblicato la notizia, ma anche per il posizionamento politico-culturale dei e delle partecipanti alla chat . Banalizzando (ci torneremo, però), stiamo parlando di persone note per il loro attivismo femminista o in qualche modo collocabili “a sinistra”.
La pubblicazione del pezzo ha aperto una discussione molto interessante, ma anche piuttosto confusa. A complicare le cose, va detto, è stato soprattutto il modo in cui altri giornali hanno ripreso la notizia data da Lucarelli (e, ahinoi, non parliamo soltanto dei media al servizio della destra al governo). Come risultato, abbiamo un dibattito in cui i piani (giornalistico, deontologico, legale, morale, metodologico) sembrano sovrapposti e ormai indistinguibili, tanto che le opinioni risultano spesso parziali o, peggio ancora, disinformate.
In questo spazio, credo sia importante fare un minimo di chiarezza circa il ruolo dei giornalisti, le scelte che si fanno quando ci si trova di fronte a notizie di questo tipo e le conseguenze che ha un certo tipo di copertura. Con una premessa essenziale: c’è una questione cruciale in tutta questa vicenda e riguarda il modo in cui le lotte femministe (fondamentali per il Paese e la società) vengono veicolate a milioni di persone attraverso i social. Ecco, su questo tema io ho un approccio che consiglio caldamente a tutti gli uomini, lettori o commentatori che siano: informarsi, ascoltare e imparare, invece di avere la pretesa di pontificare e spiegare alle donne come dovrebbero pensare, parlare e lottare. Non farò eccezione e vi rimando alla puntata speciale di Streghe, la newsletter di Fanpage.it curata da Natascia Grbic, che su questo tema ha certamente più titoli, competenze e pazienza di me (almeno in generale, stavolta è parecchio incazzata).
La scelta di pubblicare il resoconto delle chat
Prima di entrare nel campo delle “opinioni”, c’è un passaggio che va sottolineato, di natura per così dire metodologica. Subito dopo la pubblicazione, sono fioccati commenti del tipo “non si possono pubblicare queste cose”, “Lucarelli e Travaglio perderanno le cause”, “è illegale scrivere di chat private” e simili. Ora, al netto del fatto che saranno eventualmente i giudici a stabilire la liceità della pubblicazione (per la parte di competenza e sempre ammesso che ci sia qualche denuncia), è importante che si capisca che le cose sono molto più complesse. In un giornale come il Fatto, non è pensabile che un articolo di questa natura non sia stato discusso internamente, né che non si siano valutate le possibili ricadute di carattere legale. Parliamo di un giornale che ha grande expertise nella gestione degli atti giudiziari, su cui ha basato parte della sua fortuna, oltre che consulenti legali di primissimo livello.
In questo caso, parliamo di atti allegati al fascicolo del Gip e dunque tecnicamente pubblicabili. Lucarelli menziona soltanto stralci di quel materiale, dando conto del resto, come prevedono le norme. Anche applicando estensivamente le ultime modifiche legislative in materia si fa fatica a rintracciare elementi ostativi alla pubblicazione di un articolo di questo tipo, considerando, per giunta, che Lucarelli ha selezionato quei passaggi delle conversazioni che in qualche modo sembrano avere un legame con le fattispecie di reato oggetto dell’indagine. Ricordiamo che parliamo di accuse per reati piuttosto gravi, con un quadro indiziario piuttosto pesante.
Quello che l’opinionista televisiva e scrittrice prova a evidenziare, dunque, è un certo approccio, è la tendenza a organizzarsi e mobilitarsi in modo coordinato contro determinati obiettivi, sia pure in una chat privata. È la ricorsività dei trattamenti riservati a quelli che si ritiene essere gli avversari del momento, peraltro con l’utilizzo di pratiche e concetti che invece si stigmatizzano pubblicamente.
La questione principale resta quella dell’interesse pubblico, che poi costituisce una condizione fondamentale per la scriminante del diritto di cronaca. Nelle valutazioni che avrà fatto Lucarelli, sarà probabilmente entrata l’idea di avere a che fare con dei personaggi “pubblici” e che dunque la differenza tra comportamenti e pratiche pubbliche e private potesse avere grande rilevanza per i lettori.
È una questione aperta, direte voi. Mica tanto, considerando le trasformazioni degli ultimi anni e il peso nel dibattito pubblico che hanno acquisito creator, influencer e personaggi con grande seguito sui social. Parliamo di persone che totalizzano milioni di visualizzazioni, che influenzano pratiche e pensieri, che veicolano messaggi di grande rilevanza e che muovono cospicui flussi di denaro. Google ha creato un concetto per valutare il peso di siti e pagine web: YMYL – Your Money or Your Life. Ovvero, cataloga in questo modo tutti quei contenuti che trattano tematiche delicate, impattanti e spesso pericolose, proprio perché influenzano le decisioni dei lettori. Non c’è dubbio che, se applicassimo questa logica (che è frutto di profonde analisi sulle dinamiche on e off line) e la traslassimo ai social in generale, gli influencer e i creator avrebbero un peso enorme e dunque dovrebbero essere oggetto di particolare attenzione.
Certo, c'è il rischio che la sproporzione di potere che si viene a determinare (chi decide cosa è interesse pubblico? Qual è il confine? Che strumenti di difesa ex post e controllo ex ante esistono?) si concretizzi in abusi o nella replica di quello stesso schema che si intende denunciare. Restare nel campo dell'astratto è un esercizio di stile, anche doveroso, ma non aiuta a comprendere come si è sviluppato il dibattito e cosa ha riguardato.
Tanti fra gli addetti ai lavori ci tengono a farci sapere cosa avrebbero fatto loro, nel caso si fossero trovati ad avere in mano la notizia. Ma, appunto, qualunque considerazione non può che partire dal riconoscimento che si tratti di una "notizia", nel senso più chiaro che ha questo termine nel lavoro giornalistico. Dentro tale ambito, a mio parere, si può discutere delle scelte specifiche operate da Lucarelli e dal Fatto. Come, ad esempio, quella (a mio modesto parere abbastanza discutibile e sicuramente più a rischio di ripercussioni sul piano legale) di riportare stralci di conversazioni di persone non indagate e apparentemente estranee all'oggetto che ha determinato l'apertura del procedimento giudiziario in corso. Allo stesso modo, si può discutere del tono utilizzato nel raccontare la vicenda o del ricorso al cherry picking per delineare alcune dinamiche (probabilmente inevitabile, visto che parliamo di migliaia di pagine di materiale). Così come potremmo discutere delle scelte lessicali e stilistiche dell'autrice. Ma, appunto, parliamo di scelte operate in un determinato contesto, quello giornalistico, per rendere conto di un fatto con evidenti criteri di notiziabilità e per riportare ai lettori informazioni di una certa rilevanza.
Tutto sommato, per quanto il nostro lavoro sia cambiato negli anni, continua a basarsi su una serie di principi: ricerca della verità, accuratezza, continenza espressiva, rispetto delle regole deontologiche e via discorrendo. Siamo davvero sicuri che nel caso di cui stiamo parlando manchino questi presupposti?
La questione della privacy
Come dicevo, uno dei punti aperti è quello del carattere “privato” di una chat tra un gruppo di amici e del diritto alla riservatezza che tutela quella che in qualche modo può essere definita corrispondenza privata. Anche in questo caso, direi che siamo in presenza di due questioni, che non andrebbero sovrapposte. C’è sicuramente una riflessione da fare sul contenuto e sul linguaggio delle chat, che certamente alimenta la sensazione della discrasia fra immagine pubblica e “reali intenzioni” delle e degli influencer. È un aspetto che Lucarelli stressa molto, nel suo pezzo e nei successivi commenti, come spiega prima al Corriere: “L’interesse sta nel denunciare la totale incoerenza fra l’immagine pubblica che queste persone hanno costruito di loro stesse, e la negazione di quell’immagine appena si chiude il sipario pubblico. Quando c’è da confrontarsi con un pensiero critico la loro risposta è la macchina del fango”. Poi ad AffariItaliani: “Non basta dire “erano chat private”, perché il linguaggio forma la realtà, e ognuno nella sua dimensione contribuisce a disegnarne una parte”.
Sul punto, poi, vi segnalo questa articolata riflessione di Giulia Usala: “Chi parla a centinaia di migliaia di persone ogni giorno non torna cittadino comune appena chiude l’app: resta un soggetto pubblico, anche nel silenzio apparente del suo telefono. Nei loro testi, Fonte e Vagnoli invocano una nuova etica del linguaggio, la necessità di usare le parole come strumento di cura, la condanna della crudeltà mediatica. Eppure, nel momento in cui quel linguaggio ritorna come boomerang, chiedono al pubblico di spegnere lo sguardo, di dimenticare la logica che loro stesse hanno imposto agli altri. Si rifugiano nella privacy come in una tenda da campeggio montata dentro uno stadio illuminato. Il “tra amiche” non è allora un luogo di intimità, ma un artificio di potere. Non serve a proteggere la fragilità, ma a difendere l’autorità morale di chi l’ha esercitata per anni”.
Certo, andrebbe considerato che il linguaggio risente anche del contesto, che ci sono dinamiche note su come le opinioni tendano a conformarsi in determinate bolle. Non basta, a mio parere, dire "io non scrivo quelle cose in chat, non uso quel linguaggio" per ricavarne una sorta di superiorità morale. Nel nostro centimetro di libertà, nel nostro spazio sicuro, abbiamo il diritto di essere ciò che vogliamo e come lo vogliamo. Cosa diversa è quando lo spazio privato diventa motore di azioni pubbliche, quando i confini si fanno più labili. Sarebbe stato probabilmente opportuno applicare una certa dose di "carità interpretativa" alle parole scritte in momenti e ambiti particolari, considerare il contesto e omettere passaggi non rilevanti ai fini della notizia.
In situazioni del genere, tra gli addetti ai lavori ci sono approcci diversi: c'è chi interpreta in modo molto rigoroso il ruolo di gatekeeper, credendo che sia dovere del giornalista scegliere in maniera netta cosa i lettori hanno diritto di conoscere; c'è chi ritiene opportuno lasciare che siano i lettori a farsi la loro opinione, omettendo il meno possibile; chi pensa che serva un approccio diverso, reintermediando i contenuti, ovvero presentandoli al lettore assieme a tutti gli elementi per interpretarli, per inserirli in cornici di senso. Come avrete capito, chi scrive propende per quest'ultima opzione. E, tra gli strumenti che sono fondamentali per interpretare le scelte dei giornalisti e i fatti in questione, ritengo importante la conoscenza "tecnica" della questione diritto alla privacy in casi come quello di cui discutiamo.
Il precedente più recente (richiamato fin dal titolo del pezzo di Lucarelli) è quello dello scoop di un altro giornalista del Fatto, Giacomo Salvini. Come forse ricorderete, Salvini ha pubblicato diversi pezzi (poi un libro) in cui venivano riportati ampi stralci di una chat interna a Fratelli d’Italia, animata da parlamentari, ministri e dirigenti di primissimo piano del partito. In quel caso, il Garante per la privacy si era mosso con grande celerità (e in modo piuttosto anomalo, come raccontato pochi giorni fa da Thomas Mackinson sempre sul Fatto), aprendo un’istruttoria per una “possibile violazione della normativa privacy e delle regole deontologiche dei giornalisti”, che si era concentrata su una serie di aspetti: l’equiparazione delle chat alla corrispondenza privata, la pubblicazione eccessiva di virgolettati, che “potrebbe non risultare conforme al principio di essenzialità dell’informazione”, la violazione dei principi generali di liceità, correttezza, minimizzazione dell’informazione.
Ora, senza entrare nel merito della vicenda Salvini (peraltro la mia posizione in questo caso è semplice: non c’è alcun dubbio sull’interesse pubblico di quelle chat e sulla legittimità della scelta di pubblicarle), è interessante notare come la linea del giornale diretto da Travaglio sia sostanzialmente la stessa del caso Lucarelli. Rispondendo all’avvertimento del Garante, Il Fatto scriveva: “Le chat svelano il livello di ipocrisia e di opportunismo che si nasconde dietro molte esternazioni pubbliche di numerosi componenti dell’attuale maggioranza di governo. […] Abbiamo ritenuto fosse giusto che l’opinione pubblica fosse informata dei reali rapporti fra le forze politiche della maggioranza. La scelta dei testi delle chat riportati nel libro è stata guidata da un solo criterio: il diritto di cronaca e l’interesse pubblico delle informazioni, che sono state pubblicate secondo il principio dell’essenzialità, non potendo essere in alcun modo sintetizzate, come auspicherebbe il Garante”.
Nella lettura del Fatto, c’è evidentemente un’equiparazione tra politici e influattivisti, almeno per quanto concerne il loro ruolo pubblico e l’interesse dei lettori/follower a conoscere le dinamiche che portano a posizionamenti, commenti, scelte. Con ciò non stiamo dicendo che non ci sia alcuna violazione della privacy (sarà materia di approfondimento per il Garante, la magistratura e gli avvocati), ma solo che dietro la scelta di pubblicare le chat private ci sono anche ragionamenti e speculazioni sul bilanciamento tra interesse pubblico e diritto alla riservatezza.
Nel caso Lucarelli, inoltre, parliamo di atti giudiziari. E la partita si sposta anche sul “trattamento di dati personali per finalità di pubblico interesse” (consiglio questo approfondimento), che essenzialmente si basa sulla sussistenza o meno del potere dell’Autorità garante nazionale di sindacare la decisione di un organo giurisdizionale di mettere a disposizione dei giornalisti i principali atti del fascicolo di causa. In questo senso, il Garante ha finora adottato un'interpretazione molto restrittiva delle norme del GDPR, nonostante la CGUE si sia espressa in modo piuttosto diverso.
Ma è evidente che si apra un'altra questione, non di poco conto, relativamente a "cosa" è stato trascritto negli atti giudiziari e su che ragionamenti siano stati fatti per includere materiale di poca o nessuna rilevanza ai fini delle indagini. Torniamo a quel "centimetro di libertà" di cui parlavamo sopra, uno spazio privato di persone non indagate e non coinvolte in alcun modo nelle vicende oggetto dell'inchiesta, che viene esposto a seguito del sequestro di un dispositivo di terzi. Materiale che va maneggiato con cura, prima di tutto dalle procure.
Il casino combinato dagli altri giornali
Da ultimo, voglio brevemente toccare quello che considero il tasto dolente dell'intera vicenda: la copertura degli altri giornali, in particolare di quelli con enorme seguito. Dopo la pubblicazione dell'articolo sul Fatto, come spesso capita nelle redazioni ci si è interrogati su se e come riprendere una notizia che, ve l'ho spiegato, non era affatto semplice da gestire. Ognuno ha fatto le proprie valutazioni. I giornali della destra hanno scelto di attaccare "la sinistra", rea di aver coccolato il mondo dell'influattivismo globalista. Altri hanno aperto il confronto sul tema "femminismo", dando diritto di tribuna praticamente a chiunque, con prevalenza di maschi ultrasessantenni o sedicenti femministe che negli anni hanno preso posizione praticamente contro ogni battaglia femminista si possa ricordare.
Altri, Repubblica e Corriere su tutti, hanno deciso invece di contribuire al dibattito in modo parecchio (ma parecchio) discutibile: gettandosi a capofitto nelle carte dell'inchiesta, scavando nelle chat e pubblicando anche ciò che Lucarelli (e non solo) aveva escluso. Il punto più basso è stato l'aver ripescato e dato in pasto all'opinione pubblica una lista di nomi redatta dopo un disastroso call out organizzato da alcune influencer, risalente a due anni fa e ormai giustamente dimenticata. Letteralmente fango nel ventilatore, che ha colpito chi davvero non c'entrava nulla, senza alcun presupposto di notiziabilità.
Il risultato di questo delirio collettivo è stato aver fatto una grande confusione, frullando opinioni, fatti, calunnie, principi ideali e punti di diritto. È diventata una specie di lotta nel fango, in cui nessuno sa bene quale sia il proprio avversario. C'è solo fango, che ottunde i pensieri, radicalizza le posizioni e rende impossibile una discussione serena, che pure sarebbe necessaria.

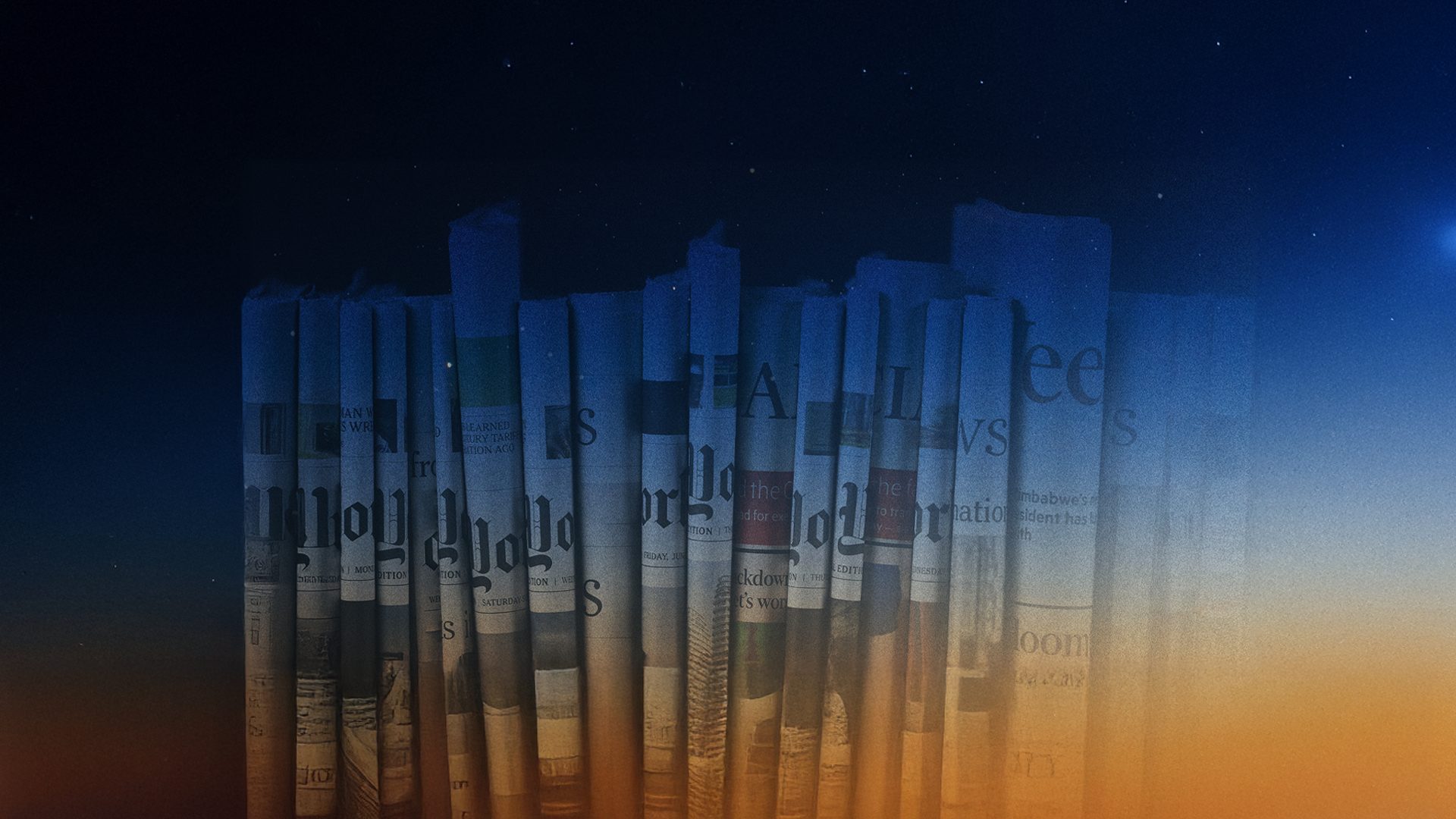;Resize,width=727;)




