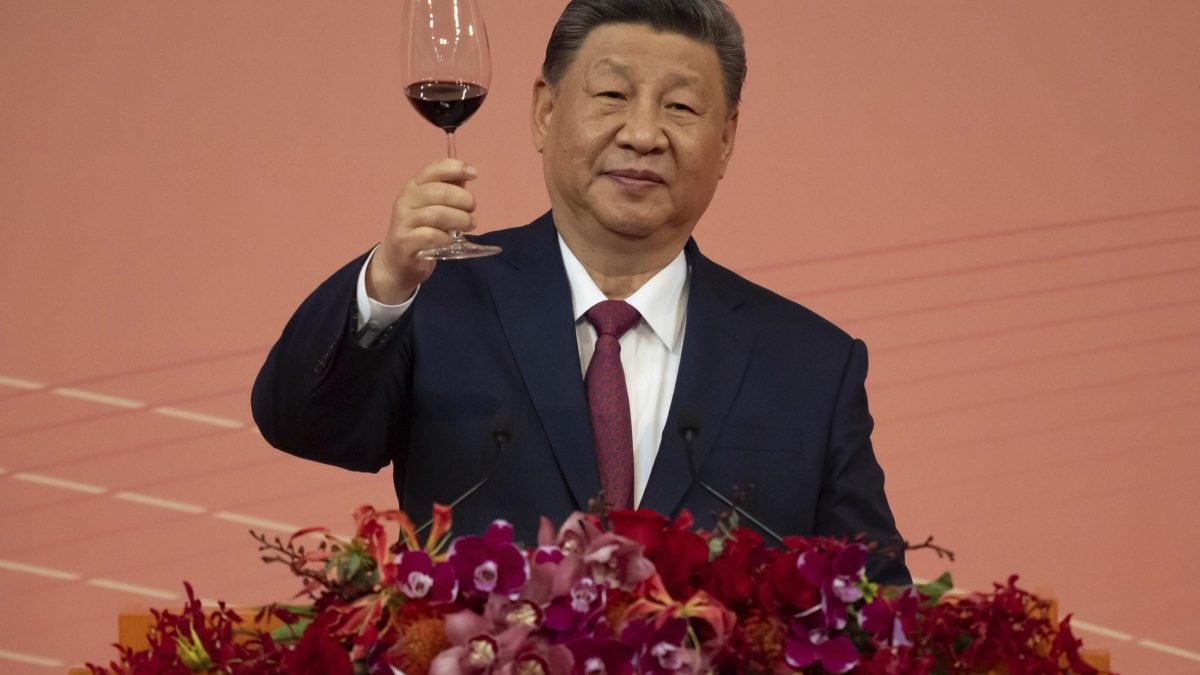
Mentre Israele bombarda le infrastrutture nucleari iraniane e gli Stati Uniti battezzano la loro “Operation Midnight Hammer”, la Cina alza la voce, ma senza alzare le mani. Nei comunicati ufficiali di Pechino, si leggono parole come “violazione della Carta delle Nazioni Unite”, “instabilità globale” e “rispetto per la sovranità”. Ma in filigrana si legge altro. La costruzione di una reputazione alternativa: quella di superpotenza che non ha bisogno di intervenire militarmente per modellare il mondo, l’unica interessata al rispetto del diritto internazionale mentre nessuno sembra più tollerarlo.
La Cina non sta con Teheran per ideologia, né contro Israele per convinzione. Sta con se stessa. Il conflitto, se limitato, è funzionale: allontana gli americani dall’Asia, fa crollare la fiducia nei mediatori occidentali, apre spazi diplomatici che Pechino può riempire con la sua narrativa multipolare e “responsabile”
Petrolio, BRI e Stretto di Hormuz: il vero campo di battaglia è energetico
La dipendenza cinese dal Medio Oriente non è un’opzione: è un assioma. Più del 40% del petrolio importato dalla Cina transita attraverso lo Stretto di Hormuz. Iran, Arabia Saudita, Emirati: sono tutti fornitori. Una crisi prolungata in quella zona colpisce Pechino direttamente al cuore – economico, energetico e infrastrutturale.
Nonostante l’Iran abbia minacciato a più riprese la chiusura dello Stretto dopo i raid americani e israeliani, la Cina non ha spinto né sostenuto questa scelta. Pechino, pur difendendo Teheran a parole, ha lasciato volutamente aperta quella valvola geopolitica, da cui transita circa il 20% del greggio mondiale. Il segnale è chiaro: la Cina non vuole destabilizzare il sistema di cui è diventata pilastro silenzioso. Sa che un’impennata del prezzo del petrolio manderebbe in recessione mezzo pianeta, a partire dai suoi partner commerciali. Invece di incendiare il mercato, lo tiene sul filo. È una dimostrazione di forza al contrario: potremmo stringere, ma non lo facciamo – per ora. E così dimostra di avere leve globali senza doverle usare.
Qui infatti entra in gioco la doppia logica cinese: da un lato, condanna gli attacchi occidentali per non perdere l’accesso alle fonti energetiche; dall’altro, sfrutta la destabilizzazione per ridurre la presenza americana nella regione, accrescere la propria e lanciare segnali. Una guerra lunga, ma non catastrofica, significherebbe anche maggior margine di manovra per la Belt and Road Initiative, oggi in stallo per instabilità e sanzioni. In gioco non c’è solo il greggio: c’è la legittimità a essere potenza sistemica.
Strategia a due volti: moralismo in pubblico, realismo in privato
Ufficialmente, la Cina è “preoccupata”. Sostiene l’ONU, invita al dialogo, offre addirittura bozzetti di mediazione multilaterale. Ma non è coinvolta in alcuna trattativa concreta. La sua vera influenza si esercita altrove: nella logistica, nella finanza, nella tecnologia dual-use.
Con l’Iran, la Cina ha una relazione non ideologica, ma funzionale. Gli ha aperto le porte ai BRICS e alla SCO, ha firmato un accordo venticinquennale di cooperazione su energia, finanza, telecomunicazioni. Non difende Teheran: lo integra nella propria visione alternativa dell’ordine mondiale. Come con la Russia, anche con l’Iran la relazione è guidata non dalla fiducia, ma dalla convenienza – e dalla comune ostilità verso l’unilateralismo americano.
Il conto ucraino: quanto costa il fronte che logora l’Occidente
Secondo il Congressional Budget Office, dal febbraio 2022 a oggi, gli Stati Uniti hanno speso in Ucraina oltre 175 miliardi di dollari, tra aiuti militari, economici e umanitari. Di questi, più di 90 miliardi sono confluiti direttamente in forniture belliche: sistemi missilistici HIMARS, munizioni d’artiglieria, droni da ricognizione, blindati, sistemi antiaerei Patriot e Storm Shadow, oltre a ingenti risorse per l’addestramento delle truppe e il supporto logistico. Altri 60 miliardi sono stati destinati al sostegno al bilancio dello Stato ucraino, al funzionamento delle istituzioni e ai servizi di base, mentre una quota crescente va alla ricostituzione delle scorte del Pentagono, che si stanno esaurendo.
Ma oltre al costo diretto, c’è il prezzo strategico: Washington ha consumato una porzione critica delle sue riserve di missili antiaerei e munizioni a guida di precisione, che richiedono anni per essere rimpiazzate. Secondo la RAND Corporation, l’industria bellica americana produce a un ritmo troppo lento per sostenere contemporaneamente Ucraina, Israele e – ipoteticamente – Taiwan. Ogni dollaro speso oggi a est dell’Europa è un dollaro in meno per contenere la Cina nel Pacifico. E Pechino lo sa. Osserva. E aspetta.
Il paradosso degli alleati asiatici: la Nato ha i muscoli, ma non le braccia
La mossa più interessante degli ultimi giorni non viene da Teheran, né da Washington. Viene da Tokyo e Seoul. I due principali alleati asiatici della Nato hanno disertato il summit in Olanda, smentendo la narrativa occidentale sulla compattezza della coalizione tra Indo-Pacifico e Occidente, e sul cordone a difesa del Mar Cinese.
Dietro le formule diplomatiche si cela un dato strategico: Giappone e Corea non vogliono essere trascinati in un'altra guerra americana, tanto meno se condotta contro un partner energetico rilevante e in un contesto percepito come troppo lontano dalla sicurezza regionale. In gioco c’è anche la tenuta di AUKUS e del sistema di alleanze regionali, già in difficoltà. La Cina lo sa, e testa i limiti della deterrenza americana, proprio dove dovrebbe essere più salda.
Taiwan sullo sfondo: Riprendersi il mondo senza sparare un colpo
Come nel 1997, quando Hong Kong tornò alla Cina senza un colpo di pistola, oggi Pechino punta a riconfigurare l’ordine globale non con le guerre, ma con le attese, le connessioni economiche, la pressione strategica silenziosa. Non conquista: si fa lasciare spazio. E quando arriva, il vuoto è già stato creato dagli altri.
Secondo questa logica, la Cina non ha bisogno di attaccare Taiwan. Le basta osservare e preparare. Mentre l’America spreca risorse in Medio Oriente e nell’Europa orientale, Pechino accumula tempo, mezzi e narrativa. Non è un caso che nel linguaggio dei media statali sia tornato il concetto di “riunificazione inevitabile”. La strategia non è bellica, è logorante: intimidazione a bassa intensità, isolamento diplomatico, dominio informativo.
Se Washington non può garantire la sicurezza energetica dei suoi partner, né quella territoriale dei suoi alleati europei, come potrà garantire la sopravvivenza di Taiwan in caso di crisi vera? La domanda si insinua nell’opinione pubblica e tra gli alleati. E Pechino si assicura che resti lì, come un dubbio strategico, alimentato giorno dopo giorno dalla distrazione americana.
Afghanistan: 20 anni di scacchi sotto gli occhi del weiqi cinese
In Afghanistan, gli Stati Uniti hanno speso oltre 2.000 miliardi di dollari – circa 300 milioni al giorno per vent’anni – per condurre una guerra che, alla fine, ha restituito il potere agli stessi talebani da cui era partita nel 2001. Un conflitto pensato con la logica degli scacchi: attacco frontale, rovesciamento del re, occupazione del centro. Ma il terreno era quello del weiqi, il gioco cinese dell’accerchiamento, della pazienza strategica, dell’erosione laterale.
Mentre la NATO bombardava, la Cina osservava e costruiva. Non ha mai sparato un colpo, ma ha circondato il campo con infrastrutture, investimenti e accordi a lungo termine. Già dal 2012, Pechino si inseriva nei vuoti lasciati dall’ISAF: miniere di rame, giacimenti d’oro, terre rare strategiche, zone industriali al confine con lo Xinjiang. Ha sfruttato la stabilità ottenuta a caro prezzo dagli occidentali per pianificare la propria penetrazione morbida, senza provocare, senza esporsi, ma tracciando linee invisibili come nel weiqi.
Non guerra fredda, ma pace calda: il commercio come trincea
Da circa 20 anni, Wang Jisi della Peking University, dice che “piuttosto che parlare di guerra fredda tra Cina e Occidente, bisognerebbe parlare di pace calda”. La Cina non fa la guerra fredda, fa la pace calda del commercio, dei contratti, delle materie prime. È tra i primi partner economici degli Stati Uniti, dell’Unione Europea e perfino del Giappone e della Corea del Sud – paesi con cui ha tensioni crescenti su Taiwan, sul Mar Cinese Meridionale, sui diritti umani. Ma il paradosso è questo: sono loro a dipendere da Pechino, non il contrario. Sulle terre rare, ad esempio – materiali essenziali per le batterie, l’elettronica avanzata e le tecnologie militari – la Cina controlla oltre il 90% della lavorazione globale.
Ha costruito un sistema a prova di sanzione, una rete che collega Iran, Russia, Africa, Asia Centrale e Sud America, da cui può rifornirsi o a cui può vendere se l’Occidente chiude una porta. Quando Canberra ha bloccato l’export di carbone, la Cina ha virato sul carbone indonesiano. Quando Washington ha imposto dazi sui chip, Pechino ha investito miliardi nell’autonomia tecnologica e nei semiconduttori "di Stato". È una strategia a ventaglio, non a muro: se una sponda cede, ce n’è sempre un’altra a cui appoggiarsi.
Il grande gioco cinese: caos controllato, silenzio utile
La Cina non cerca di vincere le guerre. Cerca di vincere nel mondo che le guerre lasciano dietro di sé. È l’unica potenza globale a non essere impantanata in alcun conflitto armato da decenni. Non certo perché sia neutrale, ma perché cerca di instaurarsi agli occhi del mondo come l’unica grande potenza responsabile. Questo accresce il suo soft power.
L’obiettivo non è salvare l’Iran, ma dimostrare che può sopravvivere alle guerre senza logorarsi, cercando di far passare un unico messaggio, ovvero che chi si schiera con lei avrà almeno una certezza: quella di non dover combattere. Quale sia il prezzo da pagare in termini di libertà, questo è un altro discorso. Ma è un discorso che riguarda ogni forma di imperialismo – che sia americano, russo o cinese – quando pretende di esportare la democrazia o ribaltare un regime. E mentre le democrazie liberali si spaccano, si indeboliscono, si inseguono in una sterile battaglia tra moralismo e interessi, la Cina capitalizza ogni crisi per rafforzare la propria narrativa: ordine, stabilità, continuità. A qualunque costo.
Se l’Europa resta divisa, disillusa e assente, non potrà più scegliere di stare dalla propria parte, né dalla parte della civiltà democratica che dice di voler difendere. Perderà l’iniziativa, il linguaggio e, infine, la possibilità di pesare. Perché nel mondo multipolare che si sta formando, la neutralità è già una forma di resa.


;Resize,width=369;)
;Resize,width=369;)
;Resize,width=369;)

