Stefano Mancuso: “Le piante sono intelligenti come l’uomo, anche senza cervello. Ma parlare con loro non ha senso”

Se leggerete i libri di Stefano Mancuso, Neurobiologo vegetale e uno dei più grandi esperti di piante al mondo, la vostra visione sul mondo vegetale cambierà completamente. Ascoltare il prof Mancuso è immergersi in un mondo fantastico, "alieno" direbbe lui, in cui si può comprendere quanto poco sappiamo di esseri viventi con cui non solo abbiamo a che fare ogni giorno, ma da cui praticamente dipende la nostra stessa esistenza. Si scopre, per esempio, che le piante sono intelligenti, molto più dell'uomo (e infatti si adattano meglio e vivono di più), che hanno memoria, che hanno percezione del mondo esterno, anche degli esseri umani, e in base a quello si sono evolute. Che pur essendo immobili non sono mai ferme. E soprattutto che vivono in armonia grazie a un sistema di collaborazione che le rende estremamente solidali. Mancuso lo scrive da anni, inizialmente lo prendevano per pazzo, oggi è uno degli scienziati italiani più importanti – direttore del Laboratorio Internazionale di Neurobiologia Vegetale (LINV) dell’Università degli Studi di Firenze, dove è professore ordinario – e il suo ultimo libro, pubblicato da Laterza si chiama "Il cantico della terra" e prende spunto dal Cantico delle Creature di San Francesco.
Quando si è innamorato delle piante?
È stato un amore adulto, come spesso accade. Le piante non sono qualcosa che di solito affascina i bambini: i ragazzi amano gli animali, perché sono più simili a noi. È lo stesso motivo per cui vediamo gli animali e non loro. Le piante sono una forma di vita profondamente diversa. Per comprenderle bisogna passare attraverso lo studio e la logica, capire che tipo di forma di vita sono. Ma una volta che lo si fa, ci si accorge di avere accanto, sul nostro pianeta, una forma di vita aliena e incredibilmente affascinante.
Qual è l’importanza delle piante per la nostra esistenza?
Se siamo qui su questo pianeta lo dobbiamo alle piante. Eppure pochissime persone, nonostante lo studino alle elementari, hanno davvero interiorizzato il fatto che dipendiamo letteralmente da loro. Tutto ciò che mangiamo dipende dalle piante: anche se mangiamo carne, quell’animale si è nutrito di piante. Sono le piante che trasformano l’energia del Sole in energia chimica, quindi in cibo. Senza di loro non ci sarebbero alimenti né ossigeno. Il pianeta sarebbe simile a Marte: una palla di roccia sterile. È sorprendente quanto sia difficile farlo capire, persino a persone colte.
Nel corso della sua carriera è stato spesso preso poco sul serio. Come ha reagito? È uno che si arrabbia?
Se fossi stato uno che si arrabbia, non sarei sopravvissuto. Oggi la situazione è cambiata, ma all’inizio, tra la fine degli anni ’90 e i primi 2000, quando parlavamo di intelligenza, memoria, apprendimento, vita sociale, comunicazione delle piante, scoppiavano veri e propri putiferi. Usavamo termini che fino ad allora erano riservati agli animali, e questo provocava reazioni violentissime: ricordo un articolo firmato da quaranta scienziati che ci definivano pazzi. Se mi fossi arrabbiato, avrei lasciato perdere. Mi ha aiutato molto anche il fatto di essere diventato professore molto giovane.
In che modo?
Mi ha dato la libertà di portare avanti le mie idee senza preoccuparmi troppo del giudizio altrui. Trent’anni dopo posso dirlo serenamente: avevo ragione io.
C’è stato un riconoscimento che l’ha colpita più degli altri?
Una trentina di quegli stessi scienziati che all’inizio mi avevano attaccato, negli anni mi hanno scritto per chiedermi scusa. È stata una delle soddisfazioni più grandi. Oggi i riconoscimenti sono molti, forse anche troppi. Recentemente la Spagna mi ha conferito il titolo di Personalità ambientale dell’anno 2025, un premio che in passato era stato dato anche a Jane Goodall. È stato molto emozionante.
Possiamo usare la nostra categoria di "intelligenza" per descrivere le piante?
È proprio questa la questione. Per anni gli editori di giornali scientifici mi hanno detto: "Va tutto bene dal punto di vista sperimentale, ma non parlare di intelligenza o memoria", perché erano categorie che volevano fossero usate per esseri umani e animali. Io rispondevo: qual è la differenza? Volevano che le mettessi almeno tra parentesi, cosa che mi rifiutavo di fare. L’idea dominante è che l’intelligenza sia prodotta dal cervello, come l’urina dai reni. Ma solo lo 0,3% degli esseri viventi – gli animali – ha un cervello. Dire che solo chi ha un cervello è intelligente significa sostenere che il restante 99,7% della vita sia composto da macchine stupide. È una follia. Qualunque forma di vita che sopravvive per milioni di anni deve risolvere problemi. L’intelligenza è questo: capacità di risolvere problemi, non il possesso di un cervello.

Un equivoco di cui parla spesso è quello per cui darwinianamente sopravvive il più forte, lei ricorda che, invece, sopravvive quello che sa meglio adattarsi. E chi meglio delle piante che si muovono anche se per noi non è così.
È una questione complessa, che nasce da una domanda semplice: perché le piante non hanno un cervello? E, più in generale, perché non hanno polmoni, uno stomaco o degli occhi, cioè quegli organi singoli o doppi tipici degli animali? La risposta è perché sono radicate. Essere radicate significa non poter mettere in atto la risposta stereotipata che noi animali utilizziamo di fronte ai cambiamenti, cioè la fuga. Quando qualcosa non va, la prima cosa che facciamo è spostarci, andarcene; poi, semmai, riflettiamo. Le piante questo non lo possono fare.
E questo cosa comporta dal punto di vista della loro organizzazione?
In un essere vivente radicato è fondamentale avere un'organizzazione robusta, cioè un'organizzazione che permetta di perdere una parte consistente del corpo senza soffrirne. Le piante sono continuamente soggette alla predazione: qualunque animale può mangiarle, eppure riescono a sopravvivere. È esattamente ciò che hanno fatto evolutivamente. Le piante hanno distribuito su tutto il corpo quelle funzioni che noi animali abbiamo concentrato negli organi. Glielo dico in un modo più semplice: le piante vedono con tutto il corpo, sentono con tutto il corpo, ragionano con tutto il corpo. Noi lo facciamo in modo più efficiente, demandando queste funzioni a organi specifici, ma siamo anche incredibilmente più fragili.
Quindi la loro struttura le rende incredibilmente resistenti?
Esatto. Basta che uno dei nostri organi venga danneggiato perché l’intera organizzazione collassi. Nel caso delle piante, invece, si può rimuovere anche l’80% del corpo e continuerebbe tranquillamente a vivere.
Uno dei nostri limiti è che esiste solo ciò che possiamo osservare. Quanto il nostro antropocentrismo influenza il nostro modo di osservare le piante?
Molto, infatti noi vediamo tutto in funzione di noi stessi. Se qualcosa non ha le nostre dimensioni, i nostri tempi o il nostro modo di agire, non lo comprendiamo. Banalità culturali, come non mangiare carne, farsi crescere la barba o indossare un cappello, sono sufficienti a farci percepire l’altro come diverso. Con le piante, che sono totalmente opposte a noi, il problema è ancora maggiore.
Quindi giudichiamo la vita solo secondo i nostri tempi e le nostre misure?
Siccome ci consideriamo il centro dell’universo, giudichiamo tutto secondo i nostri tempi. Se qualcosa è più veloce o più lento di noi, sembra "sbagliato". Anche le nostre dimensioni diventano il metro di tutte le cose: tutto viene valutato rispetto alla nostra misura. Le posso fare un esempio?
Prego.
Alla fine della sua carriera, un famoso microbiologo inglese dell'inizio del Novecento, Herbert Spencer Jennings, scrisse un enorme volume sul Paramecium, l’ameba. Sembrerebbe noioso studiare una singola cellula che si muove, ma il libro è straordinario: descrive tutto quello che queste amebe fanno. Nell’ultimo paragrafo, Jennings scrive: "Ho passato tutta la vita a studiare queste amebe e vi dico una cosa: io le ho viste cacciare, mettersi in gruppo, riprodursi, sfuggire ai pericoli, cercare i luoghi migliori per sopravvivere, comunicare tra loro. Ora, se queste amebe fossero grandi come balene, davvero penseremmo che non siano intelligenti?". Questo è un altro dei nostri problemi: giudichiamo l’intelligenza solo secondo i nostri criteri di dimensione e comportamento.
Ha senso parlare con le piante?
No, parlare con le piante non ha senso, uno lo può anche fare, io lo faccio ogni tanto, ma come dice mia moglie: "Non mi preoccupo fino a quando non mi comincerai a dire che ti rispondono".
E hanno percezione di noi e della nostra presenza?
Sicuramente percepiscono l’ambiente circostante. Le piante sono molto più sensibili di noi, letteralmente, non metaforicamente. Sono capaci di percepire l’ambiente con una sensibilità molto maggiore della nostra, semplicemente perché non possono muoversi. La loro unica possibilità di sopravvivere è capire in anticipo ciò che sta accadendo intorno a loro. Noi, che facciamo parte dell'ambiente siamo percepiti.
E come si materializza questa cosa?
Ho lavorato con elettrodi applicati sulle foglie – niente che potesse danneggiarle -, trasmettendo segnali simili a quelli dei nostri elettroencefalogrammi. La prima volta che una pianta subisce questa procedura si preoccupa e reagisce molto intensamente; nei giorni successivi, però, accade qualcosa di straordinario: impara che quegli elettrodi non sono dannosi e a convivere con la persona con cui sta lavorando, in quel caso io. I segnali, di conseguenza, diventano sempre più piccoli. È davvero impressionante. E una volta che si è abituata a me, se arrivi tu e fai esattamente la stessa cosa, i segnali saranno tre volte più grandi. Perché non ti conosce.
Perché la pianta ha memoria, come lei ci insegna.
Ha memoria e capacità di comprensione: può distinguere tra individui diversi.
Qualche anno fa parlavo con Peppe Vessicchio riguardo all’idea di far ascoltare musica classica alle piante. Ha senso questa cosa?
Guarda, con Peppe eravamo amici, è venuto tante volte in laboratorio a parlare di questa cosa. Nella forma in cui raccontava di far ascoltare la musica classica alle piante è difficile trovare una giustificazione scientifica. Quella è la nostra musica: le piante magari hanno una loro musica, ma non sarà certo quella nostra. Ci sono però alcune frequenze a cui le piante sono particolarmente sensibili, per motivi pratici. Ad esempio, le radici reagiscono a frequenze intorno ai 200 Hz: si dirigono verso la fonte del suono.
Perché?
Per anni eravamo riusciti a capirlo, poi abbiamo scoperto che quella è la frequenza principale del suono dell’acqua corrente. Quindi le piante associano quei suoni a certe cose. Per quanto riguarda la musica in senso umano, invece, non c’è alcuna base scientifica: eventuali differenze nella crescita o nel comportamento delle piante dipendono dalle frequenze ma non dalla musica in sé.
In un libro chiamato "Melanconia di classe", Cynthia Cruz parla della società neoliberista e di come l’idea di cavarsela da soli sia una bugia. Questo mi ha ricordato le piante, con la loro collaborazione sono un esempio contro il neoliberismo e il capitalismo?
Ogni volta che dico questa cosa pensano che racconti un'utopia. Le piante vivono in comunità reali, solidali: ciascuna soddisfa il proprio bisogno in armonia con le altre. Quando gli umani hanno cercato di fare lo stesso, abbiamo causato disastri. Le comunità vegetali invece lo fanno sempre. Un esempio straordinario riguarda i ceppi di alberi. Verso la metà dell’Ottocento, il botanico e chimico francese Henri Dutrochet, famoso per lo studio dell’osmosi, fu chiamato dal fratello, guardacaccia, per osservare una foresta. I registri dell’abbazia della foresta indicavano che molti alberi erano stati tagliati decenni o secoli prima. Eppure i ceppi erano vivi, ma un albero senza foglie e senza tronco non dovrebbe poter sopravvivere, tanto più dopo secoli.
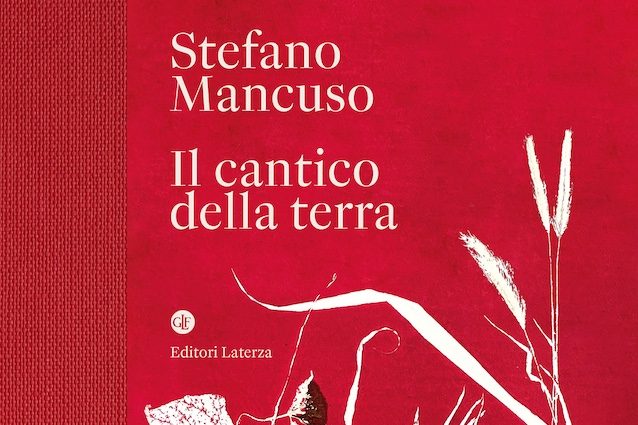
Che cosa era accaduto?
Quei ceppi continuavano a essere mantenuti in vita dalle piante vicine. Lo abbiamo scoperto solo molto di recente. E perché fanno questo le piante? Come mai hanno una forma così spinta di solidarietà, o di cooperazione, come la chiameremmo noi? A me piace definirla in un altro modo: mutuo appoggio, come scriveva Kropotkin. Perché è la maniera più efficiente per sopravvivere. Punto. Non c’è una questione etica o morale.
La grossa curiosità è questo fascino incredibile che mi suscita l’idea di semi e frutti congelati nel permafrost: sarebbe possibile ridare vita a specie che pensiamo definitivamente estinte, una sorta di Jurassic Park delle piante? E potrebbe creare gli stessi problemi raccontati nel film di Spielberg?
È una bella domanda. No, non potrebbe creare i problemi del film di Spielberg, nel senso che le piante non hanno quell’aggressività tipica degli animali che il regista attribuisce ai dinosauri. Se può accadere? Sì, addirittura è già accaduto. Nel permafrost sono stati trovati anche piccoli mammut quasi perfettamente conservati, ma gli animali, per forza di cose, si decompongono comunque, anche in quelle condizioni.
Perché, invece, con le piante la situazione è diversa?
La straordinarietà delle piante sta proprio nel fatto che i semi rimasti nel permafrost sono perfettamente utilizzabili. Il seme è una vera e propria capsula progettata per durare nel tempo. Quando li recuperi puoi farli germogliare. Ma c’è un altro aspetto importante: con lo scioglimento del permafrost, questa sorta di banca dati naturale – una banca dei semi che risale a milioni di anni fa ed era arrivata intatta fino a noi -, si sta deteriorando. Detto questo, è assolutamente possibile far rinascere piante da semi antichissimi, ed è già stato fatto, a differenza di quanto avviene per gli animali, ovviamente.
Aumentare le piante nelle città quanto aiuterebbe l’essere umano a vivere meglio? E perché non si fa, secondo lei?
Il motivo per cui non si fa non è tecnico né pratico, ma culturale. Tutte le difficoltà che vengono citate sono scuse che potrebbero essere risolte in pochi mesi. Non lo facciamo perché la nostra idea culturale di città è quella di uno spazio completamente costruito. Basta guardare le rappresentazioni delle città ideali del Rinascimento: ci sono dipinti magnifici, ma in tutti questi scenari non c’è un filo d’erba. Sono città fatte di piazze perfette, prospettive, palazzi, pozzi, chiese: tutto è costruito.
A proposito di antropocentrismo…
Abbiamo interiorizzato l’idea che la città sia lo spazio dell’uomo, un luogo in cui le altre specie non devono esistere. Ed è una follia, perché casa nostra non dovrebbe essere diversa da un contesto naturale.
Che cosa cambierebbe se smettessimo di considerare la città come qualcosa di separato dalla natura?
Immaginare una città in cui le proporzioni degli esseri viventi siano simili a quelle degli ambienti realmente naturali non è affatto un’utopia. Se aumentassimo la copertura verde delle nostre città fino al 50 o 60 per cento, non ci sarebbero stravolgimenti drammatici: si tratterebbe semplicemente di immaginare e vedere una città diversa. Non a caso, nelle poche città in cui si sta intervenendo in questa direzione — depavimentando, togliendo asfalto e inserendo piante — dopo una iniziale protesta dei cittadini, nel giro di pochi mesi tutti sono felicissimi.
Perché per il suo ultimo libro si è ispirato a San Francesco?
Per me è stato fondamentale. Ho riletto il "Cantico delle creature" dopo tantissimi anni, con uno sguardo laico e scientifico, e mi sono accorto che è una vera e propria ricetta della vita. È come se Francesco avesse letto davvero il libro della vita e avesse trovato la formula per costruirla. Di che cosa c’è bisogno perché ci sia la vita? Di un sole, di una luna, di aria, acqua, terra e fuoco. C’è bisogno di chi coopera e di chi perdona — che per me è cooperazione — e c’è bisogno anche della morte, della nostra morte. Senza la morte, la vita non potrebbe continuare. Ho preso tutti questi elementi, uno per uno, e li ho studiati e rielaborati alla luce di ciò che oggi sappiamo grazie alla scienza e all’ecologia moderna.
Infatti ha preso tutti gli elementi di cui parla Francesco.
Sì, Frate Sole, sorella Luna, frate Vento e così via, uno dopo l’altro. Li ho analizzati, studiati e descritti nei vari capitoli del libro: c’è un capitolo per ciascun elemento, riletto alla luce di ciò che oggi sappiamo scientificamente. Quello che emerge è qualcosa di davvero straordinario: è come se Francesco sapesse esattamente come funziona la vita, di che cosa c’è bisogno per crearla. È chiaramente una conoscenza mistica, profetica, perché nel Duecento non si sapeva assolutamente nulla di questi temi. Nel libro io affronto questa materia in modo un po’ particolare.
Ce lo spieghi.
È come se Francesco ci mandasse un messaggio molto chiaro: "Guardate, questi sono gli elementi che servono per creare la vita e per mantenerla in funzione. Dovete andarci cauti". Quando intervenite su parametri di cui non comprendete ancora l’importanza, le connessioni, le conseguenze, dovete farlo con grande cautela. Per me è davvero come un messaggio in bottiglia, ma all’incontrario. Di solito i messaggi in bottiglia li mandano i naufraghi per essere salvati. Qui invece è come se qualcuno, da ottocento anni, ci mandasse un messaggio per salvarci.
Il libro è dedicato a Papa Francesco, come mai?
Per me Papa Francesco è il più importante ecologo dell’ultimo secolo. Intanto perché ha scritto "Laudato si'", che purtroppo molti non leggono solo perché è un’enciclica, ma in realtà è il testo di ecologia profonda più importante mai scritto. È ineccepibile dal punto di vista scientifico ed è straordinario anche dal punto di vista umano. Papa Francesco è una persona che, da molti aspetti, ha incarnato una posizione radicale: stare dalla parte degli ultimi, comprendere che la crisi ecologica è inseparabile dalla crisi sociale. Francesco è stato una figura rivoluzionaria, ed è per questo che ho voluto dedicargli il libro.


