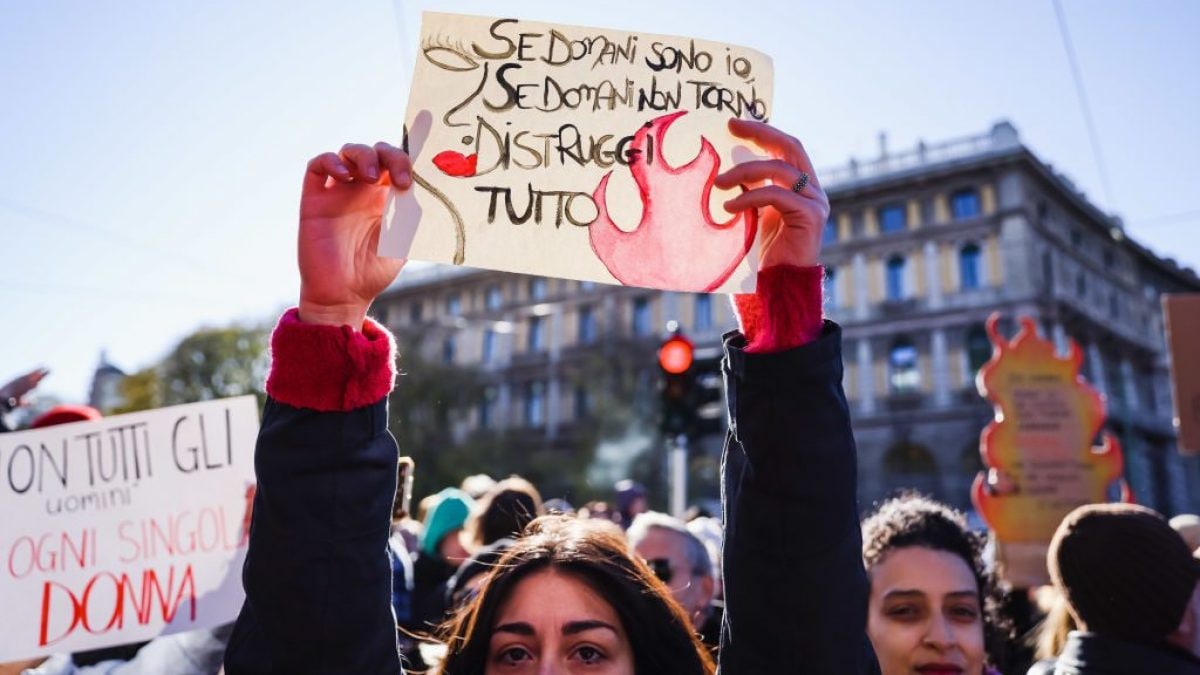
Anche il mondo della scuola si prepara al 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. In un momento storico in cui si parla molto del ruolo della scuola per prevenire la violenza di genere, anche e soprattutto a livello politico (solo la settimana scorsa c'è stata una bagarre in aula alla Camera dopo le dichiarazioni del ministro Valditara sull'educazione sessuale in classe), ci sono progetti che intendono lasciare il segno, a partire dai più piccoli. Come quello lanciato dalla Fondazione Giulia Cecchettin, che porta il nome della studentessa 22enne di Vigonovo uccisa esattamente due anni fa dall'ex fidanzato Filippo Turetta, che cercheremo di spiegare in questa newsletter.
Più avanti ci occuperemo anche delle immancabili polemiche scoppiate dopo la pubblicazione di una circolare del ministro Valditara che impone la par condicio nelle manifestazioni ed eventi negli istituti scolastici. Nel documento si evidenzia l'importanza "che l'organizzazione e lo svolgimento nelle istituzioni scolastiche di manifestazioni ed eventi pubblici aventi ad oggetto tematiche di ampia rilevanza politica o sociale, siano caratterizzati dalla presenza di ospiti ed esperti di specifica competenza ed autorevolezza".
IL TEMA DEL GIORNO

A scuola per educare all'uguaglianza di genere, il progetto della Fondazione Giulia Cecchettin parte dall'infanzia: "Così decostruiamo gli stereotipi"
Educare le nuove generazioni all’uguaglianza di genere sin dalla scuola dell’infanzia per prevenire fenomeni come quello della violenza sulle donne, che è diventato una vera e propria piaga dei nostri giorni. È questo l’obiettivo del progetto pilota per le scuole dell’infanzia e della primaria lanciato dalla Fondazione Giulia Cecchettin, nata per volere del papà Gino con l'intento di ricordare la studentessa 22enne uccisa a novembre del 2023 dall’ex fidanzato Filippo Turetta, condannato all’ergastolo.
Fanpage.it ne ha parlato con Irene Biemmi, professoressa associata di Pedagogia generale e sociale e docente di Pedagogia di genere presso l'Università degli Studi di Firenze e componente del comitato scientifico della Fondazione Giulia Cecchettin.
Prof.ssa Biemmi, ci spieghi in cosa consiste questo progetto che a breve partirà in alcune scuole italiane…
“Parliamo di un progetto pilota, una sperimentazione che partirà inizialmente in tre regioni (Veneto, Toscana e Puglia). Ci sarà un corso di formazione sull'educazione all'uguaglianza di genere che sarà rivolto alle maestre e ai maestri della scuola dell’infanzia e della primaria, per un totale di circa mille soggetti. I quali faranno anche parte di un campione di ricerca, cioè su di loro saranno svolte tutta una serie di indagini, dal punto di vista sia quantitativo che qualitativo, con la somministrazione di questionari, ma anche con Focus Group e interviste, perché c'è la necessità di condurre studi e ricerche sulla consapevolezza attuale del corpo docente rispetto a queste tematiche. In Italia mancano indagini di questo tipo. Gli/le insegnanti che lavorano oggi nella scuola italiana sono consapevoli dei temi di cui tanto si parla ormai anche nei mass-media? Cosa significa educare alla parità di genere, all'affettività, all’uguaglianza? Ecco, intendiamo rispondere a queste domande”.
Quanto durerà?
“Il progetto avrà durata biennale. Il 2026 sarà l'anno in cui si snoderà la formazione, dalla primavera a dicembre. Poi, con i dati raccolti, nel corso del 2027 verrà condotta la ricerca".
E poi cosa succederà?
“L’intenzione della Fondazione, dopo questa esperienza pilota, è quella di portare il percorso in altre regioni e allargare il progetto anche ad altre fasce d'età, per cui noi adesso ci rivolgiamo ai cicli più bassi dell'istruzione, dai 3-6 anni e dai 6-10. Ma speriamo nei prossimi anni di formare anche gli/le insegnanti della scuola secondaria di primo e di secondo grado".
Perché avete deciso di rivolgervi ai più piccoli invece che agli adolescenti?
“L'educazione alla sessualità e all'affettività deve far parte di una categoria più ampia che è quella che noi specialisti chiamiamo il campo dell'educazione di genere e della pedagogia di genere. Quindi, se l'educazione deve avere un ruolo anche di prevenzione della violenza di genere, il primo aspetto su cui ragionare è la decostruzione degli stereotipi e la parità uomo-donna. Alle medie e alle superiori, dove si deve parlare necessariamente di educazione alla sessualità, i ragazzi hanno già interiorizzato una marea di stereotipi che a quel punto sono difficilissimi da smantellare. Quindi il nostro ragionamento è: bisogna cominciare prima, dalla scuola dell’infanzia appunto, per impedire che quegli stereotipi vadano a sedimentare. È un'azione preventiva: se si educasse addirittura dal nido a un concetto di parità uomo-donna, non ci sarebbe bisogno di fare una fatica immensa durante l'adolescenza per smantellare le varie forme di sessismo che a quel punto sono già granitiche”.
Quanto è importante il ruolo dell’insegnante in questa azione?
“Tantissimo. Io credo che andrebbero formate le nuove leve di insegnanti su questa tematica, e dunque prevedere anche nel percorso di laurea in Scienze della Formazione primaria degli esami di Pedagogia di genere, che al momento non sono contemplati. Dovremmo fare in modo di spingere politicamente affinché questa cultura di genere faccia parte della formazione obbligatoria dei nuovi docenti. La seconda cosa che possiamo fare è formare invece chi già lavora a scuola, quindi chi è già in servizio. Il nostro progetto va in questa direzione”.
Eppure, molti ancora affermano che è in famiglia che si deve cominciare a dare un educazione in questo senso…
“Da pedagogista la prima cosa che mi viene da dire è che per noi è un principio chiave l'alleanza scuola-famiglia. Questo fa da base a tutti i progetti educativi che si portano avanti perché se la famiglia rema contro si va a vanificare o comunque a ridurre il potenziale di quel progetto. Va anche detto però che molte famiglie sono analfabete dal punto di vista della consapevolezza delle questioni di genere. Poi se entriamo nell’ambito dell’educazione alla sessualità si apre una voragine, perché sappiamo bene che viviamo in un paese in cui mediamente non è che i genitori abbiano familiarità su come si educano i figli a una sana sessualità. Nella mia prospettiva di scuola pubblica, c'è anche il discorso di livellare le diseguaglianze sociali da questo punto di vista”.
L'APPROFONDIMENTO
‘Educare alle relazioni': il ministero diffonde dati entusiastici sulle sue politiche, ma l'indagine non ha criteri scientifici
Ti ricordi i dati dell'indagine che il ministero dell'Istruzione ha diffuso lo scorso 10 novembre, relativa ai progetti messi in campo nelle scuole secondarie di secondo grado per il contrasto della violenza contro le donne? Stiamo parlando dell'iniziativa che il ministro Valditara ha lanciato nel 2023, sulla base delle nuove Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica, dal titolo ‘Educazione alle relazioni', che prevede percorsi e incontri sulla parità di genere e l'affettività. Viale Trastevere, trovandosi in difficoltà nel dibattito sul ddl sul consenso informato obbligatorio dei genitori per attività legate alla sessualità alle medie e alle superiori, ha voluto sostanzialmente dimostrare che il progetto sta funzionando: dal monitoraggio emerge che il 97% delle scuole che ha partecipato all'indagine del MIM (2322 scuole statali, l'86,7% del totale delle scuole secondarie di secondo grado) ha avviato in questi anni attività specifiche per sensibilizzare al rispetto delle donne e per educare alle relazione, con attività svolte durante le ore di lezione o extracurriculari. Stando a questi dati, il ministero asserisce che ci sarebbe stato un impatto positivo: nel 68,5% si sarebbe registrata una diminuzione di episodi di bullismo o violenza di genere. Il problema però è che la diffusione di queste percentuali rischia di essere soltanto un esercizio di propaganda. I dati raccolti infatti non avrebbero un vero valore scientifico, come ha messo in evidenza il CGD (Coordinamento genitori democratici), secondo cui l'indagine, condotta dal ministero tra il 15 e il 29 maggio 2025, risulterebbe poco affidabile.
I dubbi del CGD si concentrano soprattutto sugli aspetti metodologici, giudicati carenti, visto che il monitoraggio sulle scuole sembrerebbe basarsi unicamente sulla percezione di ciò che avviene negli istituti: "Secondo il ministero, quest'indagine attesterebbe l'impatto delle politiche relative all'educazione all'affettività nelle scuole. Ma per una misurazione attendibile servono studi seri e documentati – ha spiegato a Fanpage.it Carla Gueli, docente e ricercatrice dell'Università Roma Tre che collabora con il CGD – Non viene specificato chi abbia risposto al questionario del ministero. Probabilmente sono stati i dirigenti scolastici, o un gruppo vicino alla dirigenza. Ma in questo caso è difficile che vengano dati riscontri negativi, e la risposta coincide con la narrazione che la scuola fa di queste pratiche". Difficile insomma che i dirigenti, dipendenti direttamente dal ministero, dicano che il progetto è un totale fallimento. La domanda non è stata posta da un soggetto terzo, neutro, per cui la risposta sulla percezione delle scuole non può essere considerata un buon indicatore.
Ma c'è un altro problema: "Non viene specificato neanche l'oggetto dell'indagine. Quali sono esattamente i progetti svolti? Sono stati mostrati film in orario curricolare o si tratta di corsi e laboratori pomeridiani? Non viene insomma specificato la tipologia di queste attività. Sembrano insomma dei dati diffusi al solo scopo di sostenere l'idea che vada tutto bene, che queste politiche non abbiano bisogno di modifiche". In pratica un'indagine di tipo percettivo è stata proposta come se fosse solida e scientificamente fondata.
L'EVIDENZIATORE
La curiosità di oggi riguarda una ricerca pubblicata dal portale Skuola.net, che mostra un paradosso: molti studenti si trovano a dedicare più tempo ai compiti a casa che alle lezioni in aula. Su un campione di 1.100 studenti di scuole medie e superiori, il 37% impiega oltre 4 ore per svolgere i compiti assegnati; un terzo impiega circa 2-3 ore al giorno per rispettare le consegne; solo il 19% dedica ai compiti massimo due ore, mentre uno su dieci riesce a finirli in meno di un'ora. Addirittura il 15% dichiara di passare anche il weekend sui libri. Anche per via di questo carico di lavoro, sempre più spesso i ragazzi si rivolgono alla tecnologia per velocizzare lo studio: 9 su 10 si rivolgono al web e 8 alunni su 10 ammettono di ricorrere anche all'‘Intelligenza Artificiale (il 16% lo fa spesso o sempre, il 39% qualche volta). E tu che ne pensi? Le ore dedicate allo studio sono eccessive?
A cura di Ida Artiaco e Annalisa Cangemi

