Cosa sono e a cosa servono le strutture metallo-organiche premiate col Nobel per la Chimica 2025
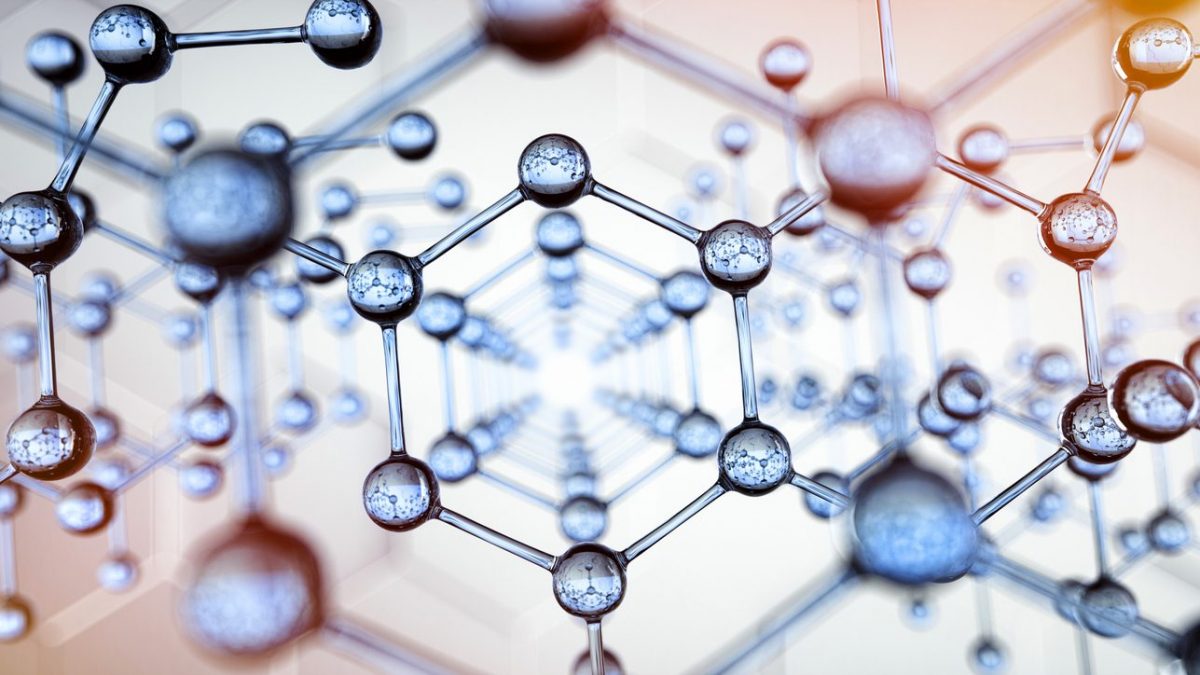
Il premio Nobel per la Chimica 2025 è stato assegnato oggi mercoledì 8 ottobre ai ricercatori Susumu Kitagawa, Richard Robson e Omar Yaghi per le loro scoperte sulle strutture metallo-organiche o MOF – acronimo di metal organic frameworks – , ovvero reticoli molecolari cristallini che combinano elementi inorganici (metalli) e composti organici a base di carbonio. Non sempre è semplice capire le applicazioni pratiche delle scoperte premiate dall'Accademia Reale Svedese delle Scienze, che tradizionalmente assegna i Nobel per la Fisica e la Chimica, ciò nonostante, in questo caso specifico, ci troviamo innanzi a materiali rivoluzionari che hanno già – e che avranno, dato che ne vengono realizzati sempre di nuovi – un impatto significativo sul progresso e l'umanità. È Esattamente ciò che Alfred Nobel ha deciso di omaggiare con il proprio testamento redatto alla fine del XIX secolo. Dunque, cosa sono e a cosa servono le strutture metallo-organiche?
Cosa sono le strutture metallo-organiche e a che servono
Come suggerisce il nome, le strutture metallo-organiche (o metallorganiche) sono materiali che combinano metalli e composti organici, in un connubio efficace tra chimica inorganica e organica. Gli elementi vengono combinati per dar vita a reticoli cristallini con struttura bidimensionale o tridimensionale (ma anche monodimensionale) ad elevatissima porosità, nei quali la gran parte del volume è occupato proprio da questi spazi vuoti. In base alle caratteristiche chimiche e fisiche degli elementi impiegati per dar vita ai MOF, si possono ottenere materiali con molteplici proprietà e dunque applicazioni pratiche. Ad esempio, i MOF possono catturare e stoccare gas come l'anidride carbonica (CO2), che è il principale dei gas climalteranti alla base del riscaldamento globale; filtrare l'acqua o altri liquidi rimuovendo metalli e sostanze tossiche come i famigerati PFAS, le sostanze perfluoroalchiliche note come “composti chimici per sempre” a causa della scarsa degradabilità in ambiente; sono inoltre in grado di accelerare determinate reazioni chimiche e permettere la separazione di composti come gli idrocarburi, modulando la porosità della struttura.
I MOF possono essere impiegati anche come sensori per rilevare la presenza di specifiche sostanze nell'ambiente e in alcuni ambiti della medicina, dalla stabilizzazione dei vaccini all'utilizzo nell'imaging diagnostico, ad esempio come mezzi di contrasto. Poiché vengono realizzate strutture metallo-organiche sempre nuove, aumentano anche i campi in cui possono essere applicate. Tra gli impieghi più rivoluzionari vi è la cattura dell'acqua dall'umidità dell'aria, anche in condizioni molto aride come quelle dei deserti. Dispositivi basati su questi materiali, pertanto, risultano particolarmente preziosi per combattere cause ed effetti della crisi climatica, rimuovendo l'anidride carbonica dall'atmosfera – in modo non dissimile da un albero – e producendo acqua nei luoghi più siccitosi, resi ancor peggiori dall'aumento delle temperature. “Le strutture metallo-organiche hanno un potenziale enorme, offrendo opportunità inaspettate per materiali personalizzati con nuove funzioni”, ha affermato in un comunicato stampa della Fondazione Nobel il professor Heiner Linke, presidente del Comitato Nobel per la Chimica.
Chi sono Susumu Kitagawa, Richard Robson e Omar Yaghi, i vincitori del Nobel per la Chimica
L'ideazione di queste rivoluzionarie strutture metallo-organiche deve tutto al pionieristico lavoro dei professori Susumu Kitagawa (Università di Tokyo), Richard Robson (Università di Melbourne) e Omar Yaghi (Università della California di Brkley), i vincitori del Nobel per la Chimica 2025. Tutto ebbe inizio nel 1989, quando lo scienziato britannico Richard Robson, classe 1937 ed esperto di metalli di transizione, combinò ioni rame carichi positivamente con una molecola a quattro bracci, le cui estremità erano attratte dal rame. Creò di fatto una struttura cristallina e ordinata con porosità rilevanti, di cui intuì immediatamente le potenziali applicazioni pratiche. Tuttavia il suo innovativo reticolo era instabile e tendente al collasso.
Fu grazie al lavoro condotto dai due illustri colleghi Kitagawa e Yaghi che tra il 1992 e il 2013 le strutture metallo-organiche assunsero una forma stabile e utile per creare progetti innovativi. "Kitagawa dimostrò che i gas possono fluire dentro e fuori dalle strutture e predisse che i MOF potevano essere resi flessibili", ha spiegato la Fondazione Nobel, mentre Yaghi creò "un MOF molto stabile e dimostrò che poteva essere modificato utilizzando una progettazione razionale, conferendogli proprietà nuove e desiderabili”.
Il professor Kitagawa, classe 1951, ha pubblicato centinaia di articoli su prestigiose riviste scientifiche, diventando membro della Japan Academy e della Royal Society per i suoi innumerevoli lavori sui materiali porosi. Il professor Robson ha lavorato nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in Australia, dove attualmente risiede. Anch'egli è membro della Royal Society e ha dedicato la sua vita di ricercatore alla creazione di polimeri. Omar Yaghi, nato nel 1965 ad Amman (Giordania) e naturalizzato statunitense, ha lavorato presso diversi atenei americani ed è membro del Lawrence Berkeley National Laboratory. Nella sua carriera, dedicata allo studio delle strutture metallo-organiche, ha conquistato numerosi premi, da Wolf al Balzan, compresa la Medaglia Luigi Sacconi della Società Chimica Italiana.


