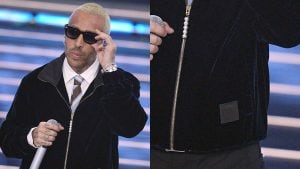Come riconoscere un bugiardo, ce lo spiega uno psichiatra: “Postura e microespressioni sono fondamentali”

Uno sguardo che sfugge verso sinistra, le dita che tamburellano sul tavolo, una goccia di sudore sulla fronte. Il corpo parla, anche quando le parole mentono. Ma come si riconosce davvero una bugia? L’abbiamo chiesto al Dott. Andreas Aceranti, psichiatra forense specializzato in Analisi Comportamentale, consulente per la Procura e per le Forze dell’Ordine e professore di Psicologia Criminale, che ci ha spiegato come leggere i segnali fisici e linguistici per individuare chi ci sta mentendo.
Che cos'è una bugia e quando diventa grave
"La menzogna non è un evento, ma un processo che coinvolge cognizione, emozione e autoregolazione. Saperla leggere richiede non solo capacità tecniche, ma anche neutralità interpretativa e controllo dei propri bias percettivi. Per questo la formazione di un analista comportamentale o di un esperto di comunicazione non verbale è lunga e complessa: si tratta di imparare non a “smascherare” l’altro, ma a comprendere come e perché il suo corpo si disallinei dalla parola", spiega l'esperto. Esistono poi sicuramente bugie innocue e bugie gravi e tra le due ci sono differenze da non sottovalutare, anche da un punto di vista della comunicazione non verbale. Come spiega Aceranti, la risposta neurofisiologica, infatti, cambia in base al coinvolgimento emotivo e alla percezione del rischio. Una bugia cosiddetta bianca, quindi socialmente accettata o motivata dal desiderio di proteggere qualcuno, non attiva con la stessa intensità le aree cerebrali del conflitto morale (cingolo anteriore e corteccia orbitofrontale) né genera una risposta simpatica marcata. Non percependo un pericolo reale, il corpo della persona, il suo tono di voce e la mimica facciale rimangono più stabili. Le bugie gravi, invece, sono quelle che implicano il rischio di essere scoperti e quindi non più socialmente accettati: per questo motivo, spiega Aceranti, attivano una cascata di risposte nel cervello. Per comprendere a pieno e riconoscere i movimenti di chi mente, Aceranti spiega che è necessario conoscere il processo scientifico che scatena nel cervello una bugia: "L’amigdala, ovvero il sistema di allarme del cervello, rileva la minaccia sociale, il cingolo anteriore segnala il conflitto interno, e il sistema nervoso autonomo innesca una reazione di stress con variazioni del tono muscolare, dell’ampiezza respiratoria e della microcircolazione cutanea". Ecco che allora nel corpo si manifestano così segnali di tensione: rigidità posturale, microespressioni di paura o colpa, alterazioni nel ritmo del parlato e della gestualità, tutti movimenti che corrispondono a un comportamento di difesa.
I segnali fisici che indicano che una persona sta mentendo
Aceranti afferma che il linguaggio del corpo è cruciale nello studio della menzogna, perché rappresenta l’unica forma di comunicazione che, pur potendo essere controllata in parte, resta radicata nei meccanismi neurofisiologici più antichi e meno mediati dalla corteccia prefrontale, che si occupa del controllo del comportamento. "Quando mentiamo, infatti, si attivano strutture celebrali che cooperano nella gestione del conflitto tra la verità e la menzogna, nel controllo dell’ansia e nell’inibizione della risposta automatica veritiera. L’atto del mentire è cognitivamente costoso: richiede memoria di lavoro, controllo esecutivo e regolazione emotiva. Tutto ciò genera una micro-disorganizzazione nel sistema di controllo motorio e autonomico" spiega Aceranti. Questa disorganizzazione si manifesta poi in segnali fisici non verbali difficilmente falsificabili, come microespressioni, cambiamenti posturali, variazioni nel tono muscolare, nel ritmo respiratorio e nel tono della voce. Dal punto di vista neurofisiologico, il corpo reagisce ancora prima della mente. Infatti, parametri come la sudorazione, la vasocostrizione periferica e la frequenza cardiaca, non possono essere volontariamente controllati. Nell’analisi comportamentale, si può affermare quindi che il linguaggio del corpo è importante perché rivela il conflitto interno tra ciò che la mente vuole dire e ciò che il corpo non riesce a nascondere. L’analisi di questi segnali, integrata con elementi del mestiere, consente di comprendere i meccanismi della menzogna in quanto fenomeno complesso che coinvolge cervello, emozioni e comportamento. Tra i segnali corporei più frequenti da individuare in una persona che mente vi sono: il micro–ritardo tra la risposta verbale e il movimento del capo (asincronia comunicativa), il cambio (o blocco) improvviso del ritmo respiratorio, microgesti di autoprotezione o autostimolazione (toccare il collo, la bocca, il viso) e, infine, una gestualità ridotta accompagnata da una postura più rigida, proprio perché la corteccia prefrontale è impegnata nel monitoraggio dell’inganno. Ovviamente, i segnali non sono universalamente sempre corretti: come spiega Aceranti, a volte ci sono persone in grado di mentire e non mostrare nessuno di questi segnali o persone che invece mostrano i segnali per altri motivi come timidezza, disagio e così via. Aceranti fa quindi un importante disclaimer affermando che lo studio del linguaggio del corpo e delle microespressioni facciali deve sempre essere accompagnato da uno studio esperto e completo.
Le microespressioni di chi mente
"Le microespressioni facciali sono contrazioni muscolari involontarie che riflettono l’attivazione del sistema limbico, in particolare dell’amigdala. Hanno una durata brevissima (tra 1/25 e 1/5 di secondo) e corrispondono alle emozioni primarie come paura, rabbia, tristezza, disgusto, sorpresa, gioia, o disprezzo, che sono biologicamente determinate e condivise tra culture diverse. Le ricerche di Paul Ekman e Wallace Friesen hanno dimostrato che, pur variando il modo in cui le emozioni vengono espresse socialmente (magari da Paese a Paese), le microespressioni spontanee restano costanti perché legate a circuiti subcorticali automatici", spiega Aceranti. Quindi, se il linguaggio del corpo è culturale e appreso dal contesto sociale, le microespressioni facciali sono universali e biologiche. Tra le microespressioni facciali più indicative in relazione alla menzogna troviamo quelle relative alla paura, che comporta la contrazione del muscolo frontale e del sopracciglio, l’innalzamento rapido delle palpebre e la dilatazione pupillare, tutti segnali che indicano la percezione della minaccia di essere scoperti. La rabbia, invece, è caratterizzata dal corrugamento del sopracciglio, dalla tensione delle labbra e dall’irrigidimento della mandibola, che segnalano frustrazione. Poi il disgusto, espresso attraverso l’arricciamento del naso e il sollevamento del labbro superiore, spesso denota il rifiuto del contenuto stesso della menzogna. La tristezza, riconoscibile per l’abbassamento delle palpebre e l’incurvamento verso il basso degli angoli della bocca, può emergere quando la bugia entra in conflitto con valori morali o affettivi. Infine, la sorpresa è visibile nel sollevamento improvviso delle sopracciglia e nell’apertura parziale della bocca, seguite da un'espressione neutra che è tipica di chi deve improvvisare una risposta inattesa. Aceranti lo ripete, queste microespressioni non rivelano direttamente la menzogna, ma mostrano l’emozione reale che il soggetto tenta di nascondere.
Oltre il movimento, riconoscere una bugia attraverso il tono e le parole
"La voce e il tono contano quanto, e talvolta più, dei gesti nel riconoscimento di una menzogna, perché sono direttamente influenzati dal sistema nervoso autonomo e dalle microvariazioni di attivazione limbica. Il linguaggio paraverbale, cioè intonazione, ritmo, volume, timbro e pause, costituisce una finestra diretta sull’attivazione fisiologica del soggetto, molto prima che il controllo corticale possa modulare il linguaggio corporeo", afferma Aceranti. Durante una menzogna, infatti, si produce una lieve tensione nei muscoli laringei e una variazione nel flusso respiratorio, da cui derivano tremolii o incrinature vocali, variazioni del ritmo e del tempo di attesa tra domanda e risposta. Anche il controllo respiratorio incide molto: una bugia impegnativa richiede più ossigeno, ma la persona tende a ridurre l’ampiezza respiratoria per mantenere il controllo, generando così un tono più acuto. Per quanto riguarda la voce, infine, una narrazione coerente e sincera mantiene l'armonia fra contenuto, ritmo e tono, mentre una bugia introduce piccole dissonanze che tradiscono il tentativo di compensare l’incongruenza.
Come vengono lette le bugie dalla polizia e da un osservatore non esperto
Aceranti spiega che "Distinguere in modo affidabile verità e menzogna richiede anni di esperienza, formazione specifica e una solida conoscenza dei meccanismi neurofisiologici e psicologici che regolano il comportamento umano. L’errore più comune dei non esperti è quello di cercare “segni della menzogna” isolati, come lo sguardo distolto o i gesti nervosi, senza considerare il contesto, la personalità e la linea di base comportamentale del soggetto". Un analista esperto, invece, costruisce un profilo dinamico che include tutte le variabili del caso. In polizia, infatti, gli strumenti per capire se una persona sta mentendo sono numerosi ma utili solo se inseriti in un quadro operativo d'insieme. C'è il poligrafo, che misura parametri fisiologici come frequenza cardiaca, conduttanza cutanea, respirazione e pressione arteriosa, i più recenti strumenti di neuroimaging funzionale, come la risonanza magnetica funzionale e l’elettroencefalografia quantitativa, che consentono di osservare l’attività cerebrale, anche se queste ultime rimangono sperimentali. Infine, nelle indagini reali si utilizzano protocolli precisi durante le interviste, come la Cognitive Interview (Intervista cognitiva) o il modello SUE (Strategic Use of Evidence), che mirano a far emergere incongruenze tra memoria dichiarata e comportamento non verbale.