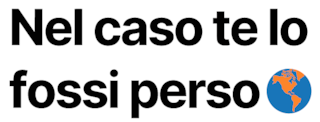Segui Nel caso te lo fossi perso.
Ascolta la notizia più importante del giorno.

Sono passati 10 anni esatti dagli Accordi di Parigi sul clima, quegli accordi che puntavano a mantenere l’aumento delle temperature sotto gli 1,5 gradi rispetto al periodo preindustriale. Degli obiettivi che ora, per le temperature registrate negli ultimi anni, appaiono già falliti. La COP30 che inizierà ufficialmente a Belém il 10 novembre parte male. Un po’ perché si dovrà confrontare con un fallimento generale della strategia adottata finora, e un po’ perché in realtà non sembra fregargliene più di tanto a nessuno.
La giornata dei leader alla COP30: chi era assente
Ieri e oggi, tra il 6 e il 7 novembre, erano le giornate dei leader. Cioè i giorni in cui i leader mondiali si dovevano ritrovare prima dell’inizio dei lavori della COP, cioè della conferenza delle Nazioni Unite sul clima, per discutere dei temi e degli obiettivi in agenda. Il problema è che questa volta si sono presentati solo 60 tra capi di Stato e di governo. Ed è l’ennesimo segnale del fatto che la lotta al cambiamento climatico non è più una priorità, non è più centrale nelle politiche degli Stati e in quelle internazionali.
Il grande assente è Donald Trump, e questo chiaramente è un problema. Perché il negazionismo climatico statunitense compromette qualsiasi altro tentativo di invertire la rotta e questo non è qualcosa che il globo terrestre si può permettere in questo momento. Ma Trump ha ritirato gli Stati Uniti dagli accordi di Parigi per ben due volte, non ha inviato nessun funzionario di alto rango alla COP, continua a ridicolizzare gli attivisti climatici e a tagliare sull’energia pulita, mentre promuove i combustibili fossili, cioè i principali responsabili delle emissioni inquinanti che poi comportano l’innalzamento delle temperature e gli squilibri climatici che a loro volta generano sempre più eventi estremi.
Non è andato in Brasile nemmeno Xi Jinping, il presidente cinese, leader di uno dei Paesi più inquinanti del mondo. E non ci sarà nemmeno Giorgia Meloni, che ha deciso di inviare al suo posto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Gli altri principali leader europei, da Emmanuel Macron a Ursula von der Leyen, invece saranno presenti, ma questo non toglie che l’Europa abbia nettamente cambiato il suo approccio nella lotta al climate change negli ultimi anni. Se il Green Deal era stato il grande protagonista della scorsa legislatura, con l’Unione europea che si era data degli obiettivi tanto ambiziosi quando necessari, in primis quello di diventare il primo continente ad emissioni zero entro il 2050, da quando è cambiata la maggioranza politica a Bruxelles un anno fa, anche l’impegno contro il climate change è mutato profondamente.
Come è cambiato l'impegno dell'Europa sul clima
Con le elezioni del 2024 la destra più a destra ha conquistato più potere e peso politico, mentre i Verdi e in generale l’agenda ecologista dei partiti di sinistra sono stati nettamente ridimensionati. E quindi si è cominciato a parlare di rivedere una strategia descritta come insostenibile, si è iniziato a puntare il dito contro una politica definita ideologica, si è contrapposta una sostenibilità ambientale a una sostenibilità economica. Questa forse è la cosa più grave, che però la propaganda negazionista è riuscita senza dubbio a veicolare nel suo messaggio: ma dobbiamo dirlo chiaramente, non ci può essere sostenibilità economica senza sostenibilità ambientale. I danni degli eventi climatici estremi li stiamo già pagando a prezzi altissimi, gli squilibri climatici renderanno alcune zone del pianeta inabitabili e chiaramente questo avrà un impatto anche sull’economia di quelle comunità e poi, a cascata, su quella globale.
Le due cose sono fortemente collegate e metterle in contrapposizione va contro gli interessi di tutti. Con questo non significa ovviamente che la transizione non vada accompagnata, sicuramente cambiare le nostre forniture energetiche, alimentari, stravolgere la nostra mobilità e le catene produttive, ha un impatto economico. Ma il punto non è negare questo cambiamento, il punto è trovare le modalità di adattamento che non lascino indietro nessuno.
Tutto questo, però, non sembra più essere in cima alla lista delle priorità dell’Europa. Appena qualche giorno fa l’Unione europea ha raggiunto un accordo di compromesso sugli obiettivi climatici che si era data per il 2035 e il 2040, concedendo una flessibilità maggiore a quella inizialmente prevista. Perché lo ha fatto? Perché alcuni Stati, in primis l’Italia di Giorgia Meloni, minacciavano di mettersi di traverso e far saltare tutto se non fossero state inserite negli accordi alcune clausole, volte appunto ad ammorbidire degli obiettivi giudicati non solo insostenibili, ma anche fondamentalmente sbagliati.
La lotta al cambiamento climatico non è più una priorità
Sulla carta le cifre sono rimaste le stesse, cioè una riduzione del 90% delle emissioni di gas serra entro il 2040, rispetto ai livelli del 1990, ma con una buona dose di elasticità. Ad esempio, per raggiungere questi numeri gli Stati membri potranno finanziare anche progetti al di fuori dall’Ue, una misura che secondo molti finirà per essere una scappatoia che annacquerà gli obiettivi. Insomma, con questo compromesso la strategia europea per la riduzione delle emissioni è molto più debole di quanto non voglia far sembrare quel taglio del 90% nei prossimi 15 anni.
E questo è forse l’elemento più preoccupante a livello internazionale. Perché lascia la lotta al cambiamento climatico senza un traino, che invece l’Unione europea doveva rappresentare, anche in quanto rappresentante del mondo industrializzato, quello che ha inquinato di più nella storia.
Dieci anni dagli Accordi di Parigi
Dieci anni fa gli accordi di Parigi erano la concretizzazione di un impegno politico senza precedenti nella lotta al cambiamento climatico. Ora, tra il negazionismo statunitense e il cambio di rotta dell’Unione europea le cose sono cambiate. E a rimetterci però non saranno gli Stati Uniti e l’Europa: o meglio, ne risentiranno anche loro, ma non saranno colpiti allo stesso modo dagli effetti del cambiamento climatico come il Sud globale. Che è più vulnerabile e più esposto alle ondate di calore estremo, alle siccità, all’innalzamento dei livelli del mare, alle alluvioni e agli uragani.
Il 2024 è stato l’anno più caldo mai registrato e il 2025 sembra seguire la stessa tendenza. “Il mondo ha fallito, è impossibile evitare l’aumento delle temperature oltre gli 1,5 gradi” ha detto il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, chiedendo poi ai leader mondiali di non tradire ulteriormente gli impegni che avevano sottoscritto dieci anni fa, perché “prigionieri degli interessi radicati” delle imprese che investono nel fossile, delle lobby che proteggono l’arricchimento economico di pochi. Il problema è che in platea c’erano ben pochi leader ad ascoltarlo.
Se questo contenuto ti è piaciuto, clicca su "segui" per non perderti i prossimi episodi.
Se vuoi accedere ad altri contenuti esclusivi e sostenere il nostro lavoro, abbonati a Fanpage.it!

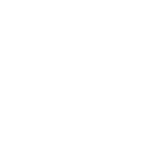
;Resize,width=727;)