Iscriviti a Evening Review.
Ricevi la rassegna speciale a cura di Adriano Biondi

Alla vigilia delle Elezioni Europee tra gli addetti ai lavori ci si domandava quanto fosse sensato prendere sul serio Roberto Vannacci e quale potesse essere la sua reale dimensione politica. Almeno per una volta, non si trattava di snobismo o di pregiudizi, ma di evidenziare le tante incognite sul Vannacci politico, considerando il modo del tutto peculiare in cui era salito alla ribalta e le circostanze in cui era maturata la candidatura al Parlamento Europeo (in sintesi: la disperata ricerca di qualcuno in grado di aumentare i consensi per la Lega e salvare la poltrona di Matteo Salvini). Non in subordine, ci si domandava quale fosse il reale standing del generale, alla luce delle idee sconclusionate e della grammatica traballante dei suoi due prodotti letterari, nonché di una serie di apparizioni pubbliche piuttosto discutibili.
Come spesso accade, riflessioni di questo tipo erano passate in secondo piano dopo il risultato elettorale. Nonostante il generale si aspettasse molto di più e al netto della strategia autolesionista di Salvini (che aveva finito con l’oscurare la quasi totalità degli altri candidati leghisti), con onestà intellettuale va riconosciuto il successo della sua candidatura tra gli elettori. Non una sorpresa, forse, ma un fatto politico di un certo interesse. Nel tempo dello spontaneismo, quello in cui autenticità e schiettezza hanno preso il posto di competenza e preparazione, la nascita di fenomeni come Vannacci è quasi automatica. La loro evoluzione, invece, è sempre incerta, come testimoniano le tante fiammate che si sono spente rapidamente negli ultimi anni. Al momento, il generale è in mezzo al guado: sta facendo carriera nel partito in cui non voleva entrare e non sta riuscendo a far decollare il movimento che voleva fondare.
Tuttavia, quello dell'europarlamentare della Lega costituisce un caso decisamente interessante, soprattutto per la distanza che passa fra le sue ambizioni, i concreti margini di manovra sullo scenario e le considerazioni dei suoi interlocutori sul piano politico – istituzionale. La domanda che dovremmo porci, in tal senso è: possiamo davvero prendere sul serio Roberto Vannacci? O meglio, quanti prendono davvero sul serio il generale nella sua avventura politica e che sviluppi sono ipotizzabili?
Sulla reale consistenza del progetto politico, come dicevo, ci sono più dubbi che certezze. Le prime iniziative, diciamolo con grande franchezza, non sembrano molto incoraggianti, tra scarso interesse, beghe interne e le prevedibili difficoltà nel radicamento territoriale che qualunque nuova formazione politica si trova ad affrontare in questa particolare fase storica. La militanza nella Lega non è delle più serene, per usare un eufemismo, considerando che il generale è visto da alcuni come un’insidia per Salvini, da altri come un corpo estraneo e da altri ancora come un elemento che rischia di portare a un’ulteriore radicalizzazione (e di conseguenza all’emarginazione) di un partito che ha ormai da decenni una dimensione di governo, sia territoriale che nazionale.
Da qualche tempo, tra i bene informati, circolano voci di una grande insofferenza di Giorgia Meloni rispetto alla possibile crescita e consolidamento del fenomeno Vannacci. Secondo tale lettura, la presidente sarebbe preoccupata perché il generale sembrerebbe poter parlare a un elettorato a lei molto vicino, catalizzando inoltre la delusione di chi si aspettava ben altro impatto dalla vittoria elettorale del centrodestra e dai primi tre anni di governo. Meloni sa benissimo di non aver mantenuto la promessa di rivoluzioni e cambiamenti epocali, optando per logiche conservative che in alcuni casi sono apparse addirittura in continuità con le precedenti esperienze di governo. E sa altrettanto bene, per averne beneficiato direttamente, che professare la radicalità senza alcuna responsabilità di governo può rendere bene sul piano del consenso elettorale. E se l’orizzonte, l’unica cosa che conta, è quello delle Politiche del 2027 (lo ripeto, si tratterà di scegliere soprattutto chi eleggerà il prossimo presidente della Repubblica), il generale potrebbe davvero essere la crepa (o una delle) nella costruzione della leader di Fratelli d’Italia.
Ma la domanda resta: Vannacci ha la forza, le competenze e l’autorevolezza per fare il definitivo salto di qualità sulla scena politica? Spesso la risposta che si sente ripetere a domande del genere suona tipo “lasciamo che a decidere siano gli elettori”. E se non c’è dubbio che la legittimazione popolare sia fondamentale, allo stesso tempo il rischio è dimenticare che il consenso elettorale si muove secondo dinamiche complesse, che non sempre sono in correlazione diretta con la qualità del messaggio e la struttura di chi lo veicola. Sono tanti i fattori che entrano in gioco: dallo spazio e dal tempo necessari per la penetrazione delle istanze alla caratura del leader di riferimento, passando per la forza (economica, politica, relazionale) di cui si dispone per far circolare le idee, fino ad arrivare alle strutture in grado di sostenere un progetto politico.
Da questo punto di vista, il cammino del generale Vannacci sembra essere davvero in salita. Anche nella considerazione dei suoi colleghi, che faticano a rintracciare un'evoluzione, una crescita, un salto di qualità nella proposta vannacciana. Come vi avevo raccontato qui, è ancora considerato colui che “indossa la maschera del conservatorismo spicciolo, dello zio attempato al pranzo di Natale che rimpiange i bei tempi andati”. Fermo nella sua idea del “mondo al contrario”, con visioni retrograde e antistoriche, ma soprattutto superficiali e impossibili da concretizzarsi.
La parola chiave della sua piattaforma, che condiziona tutta la sua comunicazione, è “buonsenso”. Un ombrello che fornisce riparo a qualunque scempiaggine: dalla remigrazione alla pretesa “non normalità” dell’omosessualità, fino alle valutazioni di carattere storico-politico e culturale. Su quest’ultimo punto, vale la pena di dire due parole, considerando che si tratta degli ambiti prediletti dal generale Vannacci, che, forse riconoscendo una certa impreparazione sul piano amministrativo/gestionale, si è auto-eletto maitre a penser di una corrente piuttosto composita (anti-woke, anti-globalista, neoconservatrice e via discorrendo).
Partiamo da una considerazione: nel merito, c’è poco da dire sulle sparate di Vannacci sul fascismo, sulla storia recente del nostro Paese o sulle “ricette” in tema di flussi migratori. Nel migliore dei casi, il generale dice sciocchezze: fa confusione, è impreciso, non sa cogliere i nessi causali fra i fatti, rilancia bufale o interpretazioni fallaci. Le ultime scemenze sul fascismo e sulla presa del potere di Mussolini sono di una pochezza tale che lo stesso Salvini si è limitato a scrollare le spalle, parlando di esperienza “sconfitta dalla storia” e invitando tutti a concentrarsi sul futuro.
Per inciso, non si tratta di niente di nuovo. Quello che dice adesso Vannacci (la banalizzazione della violenza fascista e la trasformazione della dittatura mussoliniana in una sorta di governo autoritario ma tutto sommato efficace) lo sentiamo e lo leggiamo da anni in Rete, nei talk show, sui giornali della destra, a volte persino in Parlamento. Certo, un simile livello di normalizzazione e legittimazione della brutalità fascista probabilmente non si era mai raggiunto, ma questo è un problema che si pone ben oltre Vannacci, come testimoniano i fatti di Parma e ancora la nostra inchiesta su Gioventù Nazionale, i “giovani meravigliosi” della presidente del Consiglio.
Ma la sensazione è che l’insistenza del generale su questo tema (che sfiora punte di ridicolo come nel caso dei continui rimandi alla Decima Mas), abbia semplicemente lo scopo di non far calare l’attenzione sulla sua figura politica. Vannacci ha bisogno del conflitto, ha bisogno di avere uno scopo, di tanti posizionamenti spot. Ha bisogno che si parli di lui, soprattutto che lo facciano quei soggetti che la sua fanbase disprezza (politici di sinistra, influattivisti e giornalisti). Ha bisogno di testare le reazioni dell’opinione pubblica, alzando di volta in volta l’asticella, in modo da ottenere non solo visibilità, ma anche uno spazio in cui inserire la propria visione politica.
È una sorta di variazione della tecnica del trial balloon, di cui sono maestri i suoi alleati al governo. Normalmente funziona così: quando si intende prendere una decisione importante, magari proporre una legge particolarmente impattante, allora ci si organizza per far trapelare piccole anticipazioni al rialzo su quel tema, o si rilascia qualche battagliera dichiarazione; si osservano le reazioni dell’opinione pubblica e si interviene poi “ufficialmente”, per smentire, precisare o tranquillizzare; in base al dibattito che si determina, si ottengono informazioni utili a impostare il provvedimento, che poi viene annunciato in un ambiente che in qualche modo si è già “abituato” e a persone che sono più propense ad accettarlo. Per fare un esempio: se volessi imporre a un gruppo di cittadini una tassa per chiunque possieda un’automobile di valore superiore ai 50mila euro, io potrei cominciare a far trapelare le voci su interventi per “tutte” le auto, magari mandando qualche ministro a dire che è necessario “colpire chi inquina” e cose del genere. Dal dibattito che ne scaturirebbe potrei ottenere informazioni su come calibrare il provvedimento (o se cancellarlo), ma in ogni caso quando presenterò il piano limitato alle auto di oltre 50mila euro di valore troverò, se non consenso, quantomeno sollievo in tanti che avevano “temuto” di essere colpiti da una tassa più dura.
Vannacci, chissà quanto consciamente, fa lo stesso con una frequenza impressionante. Ora, per esempio, se l’è presa con una donna, Mia Bintou Diop, indicata dal nuovo presidente della Toscana come sua vice. Le dichiarazioni sono risibili: “A sinistra zero polemiche per la nomina a vicepresidente della Toscana di Mia Diop, 23enne studentessa senegalese, senza alcuna esperienza. Basta la tessera PD e la pelle nera. Venezi? Di destra, bianca, bionda, cristiana… e pure competente. La verità fa male”.
Risibili perché Diop è una politica seria, che ha già anni di esperienza nel PD. Logicamente fallaci perché Beatrice Venezi non c’entra nulla, essendo casi completamente diversi. Stupide perché Diop è italiana. E strumentali per il richiamo razziale, che serve da collegamento a quella che è la nuova sciocchezza vannacciana per eccellenza: la remigrazione. Conta però poco: il generale è sui giornali, si fa strada l'idea che Diop sia un'anomalia, ci si abitua alla normalità di discorsi discriminatori.
So già qual è l'obiezione di fronte a considerazioni di questo tipo: "Eh, ma basta non dargli spazio, siete voi che lo aiutate a diffondere i messaggi". Faccio però notare che parliamo di un europarlamentare eletto con numeri record, che dunque dovrebbe rispondere a tutti i cittadini delle posizioni che prende; di un vero e proprio influencer, che ha la forza di far circolare e rendere virali i contenuti; di un rappresentante di un partito che è al governo del Paese, della cui linea politica si fa interprete. Ignorarlo non è e non sarà mai la soluzione. Lasciarlo fare, legittimandone le sciocchezze senza contraddittorio, nemmeno. Dare ai cittadini gli strumenti per interpretare le sue tecniche comunicativi e smontarne le scempiaggini, forse può aiutare.

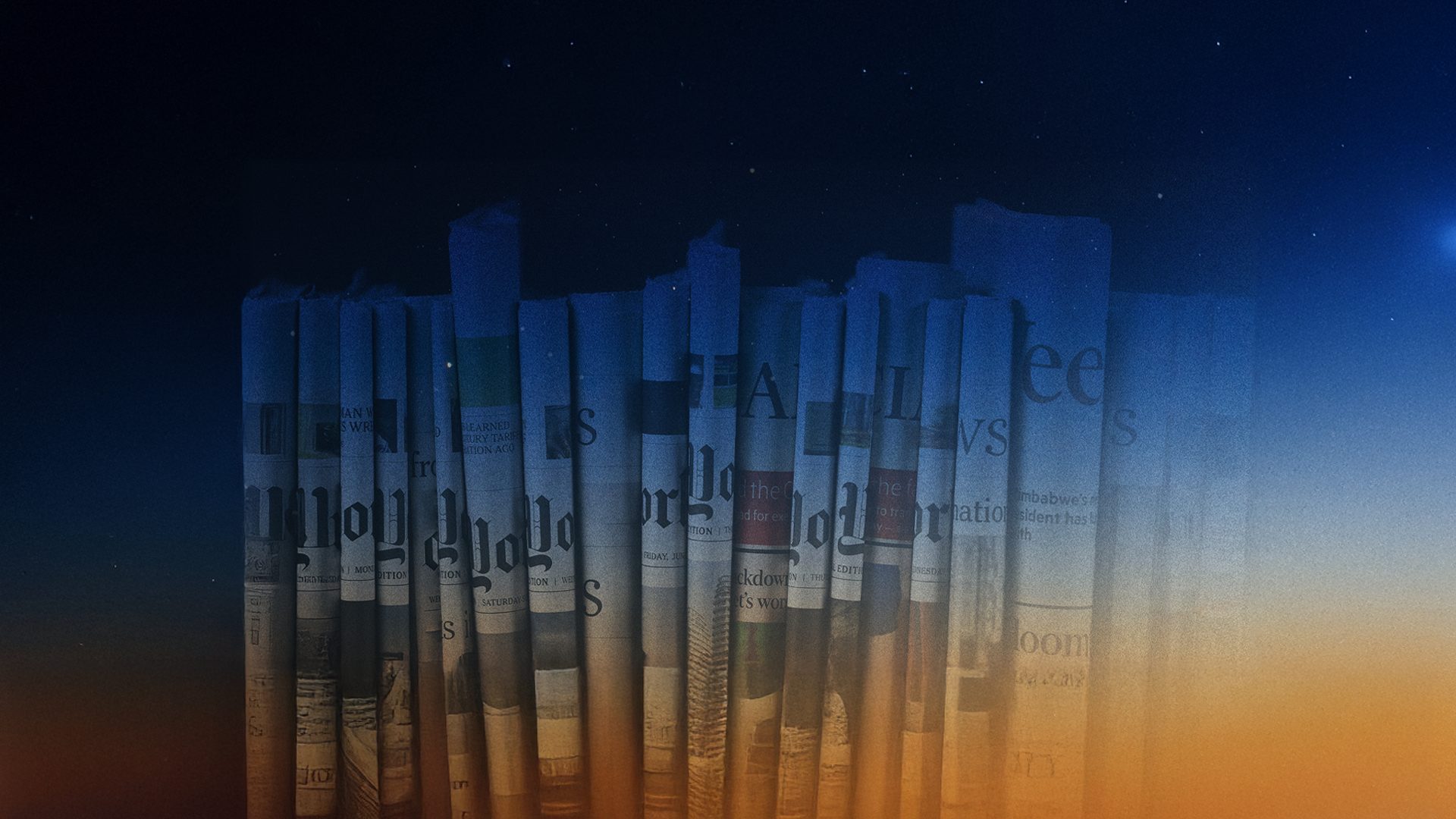;Resize,width=727;)




